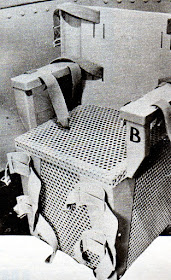 |
| La sedia elettrica del carcere americano di San Quentin |
L’esecuzione
ebbe luogo in una grande sala. Non all’aperto, non pubblicamente
come al solito. Lo aveva deciso la regina Elisabetta I in persona: la
sua rivale scozzese, Maria Stuarda, doveva essere decapitata nel
Salone delle Feste del castello di Fotheringhay.
Era
l’8 febbraio 1587. Verso le otto del mattino i trecento ospiti
poterono assistere all’ingresso della condannata che, tranquilla e
dignitosa, salì sul patibolo. Alla luce tremolante di un grande
camino ebbe inizio una cerimonia che sarebbe durata due ore: con
lunghe preghiere, scene di addio, ingressi a effetto di sacerdoti e
magistrati. Solo poco prima delle 10 entrarono i due carnefici:
secondo la vecchia usanza chiesero perdono alla condannata per ciò
che stavano per farle. Maria Stuarda si tolse il velo nero, si lasciò
bendare gli occhi e, vestita di una sottoveste purpurea (il colore
dei martiri), si inginocchiò e posò il capo sul ceppo. Il boia alzò
la scure.
Quello
che accadde poi rovinò tutto l’effetto della messinscena. Il primo
colpo di scure spaccò la nuca della condannata. Ce ne vollero altri
due per staccare dal tronco la testa della vittima. E quando il boia
la sollevò per i capelli, la testa ruzzolò a terra: Maria Stuarda,
nell’ora della morte, portava una parrucca.
Secondo
lo scrittore tedesco Karl Bruno Leder, autore di un libro appena
apparso nelle librerie tedesche sull'origine e la storia della pena
di morte (Todestrafe, Meyster Verlag, 1980), anche Maria
Stuarda, come già la maggior parte dei condannati a morte prima di
lei, ha accettato di recitare, nella pomposa e drammatica messa in
scena della propria morte, il ruolo principale «senza opporre la
minima resistenza», anzi «in modo esemplare». Perché? Per vanità,
per rassegnazione o perché, paralizzata dalla paura, obbediva
meccanicamente alle disposizioni della regìa? Nel suo libro Karl
Bruno Leder cerca di rispondere a questa domanda. Anzi, cerca di
trovare una risposta al perché della «pena di morte», al perché
di questo «desiderio di punire» con l’annientamento fisico.
Tutti
i suoi predecessori che si sono occupati della pena di morte, lo
hanno fatto per combatterla, dimenticandosi di porsi la questione
principale: perché torna sempre la richiesta di pena di morte?
Nel
Settecento Cesare Beccaria e Voltaire, Victor Hugo (con L'ultimo
giorno di un condannato e altri, numerosi, scritti sulla pena di
morte) il secolo scorso e Albert Camus negli anni Cinquanta, si
scagliano contro la «barbarie pubblica» di uccidere chi è ritenuto
colpevole e l’assurdità logica e morale della pena ui morte, ma
non ne ricercano l’origine.
Karl
Bruno Leder, per spiegare l’insistente desiderio di punire
attraverso la pena di morte, ha messo da parte le più recenti
spiegazioni sociologiche e psicanalitiche ed è risalito alle
origini. Secondo Leder essa non nasce come espressione di giustizia:
al di là di ogni legge e giustizia, della colpa e dell’espiazione
individuale, la pena di morte avrebbe origine nella penombra della
preistoria.
Nelle
società più antiche il sacrificio umano veniva praticato per
evitare la vendetta delle forze della natura nei confronti degli
uomini che infrangevano i tabù. La sciagura minacciava tutta la
collettività e non solo il singolo che aveva infranto il tabù. Il
sacrificio umano serviva dunque a eliminare le paure e i sensi di
colpa collettivi.
Questo
magico «sistema del capro espiatorio», secondo Leder, subì
trasformazioni durante l’evoluzione storica: nei tempi più antichi
venivano sacrificati i membri più preziosi della comunità, come i
bambini, i primogeniti maschi, le figlie vergini. Più tardi le
vittime cambiarono: erano stranieri, prigionieri di guerra, schiavi e
infine, sempre più spesso, malfattori. E solo nel corso di questa
evoluzione che, secondo Leder, «il sacrificio umano, alla fine,
divenne la pena di morte».
Originariamente
la stretta correlazione tra sacrificio individuale e pena di morte
era chiaramente riconoscibile. I criminali non venivano quasi mai
direttamente uccisi: venivano banditi e scacciati in luoghi selvaggi,
delegando così l’esecuzione alle forze della natura. Più tardi,
un lancio di pietre accompagnò l’atto dell’espulsione. Tutta la
comunità doveva prender parte a quest’atto (che avrebbe poi
portato alla lapidazione): solo così, secondo Leder, poteva venir
superata l’«inibizione a uccidere».
Questa
«inibizione» è presente in molte forme primitive di esecuzione.
Quando il condannato veniva crocifisso, appeso per i piedi, affogato
o bruciato, gli esecutori non provocavano direttamente la morte delle
vittime. Secondo l’autore, il prolungamento delle orribili
sofferenze del condannato molto spesso non era provocato dal sadismo,
ma piuttosto dal tabù dell’uccisione, dal timore del morto.
Fino
al Seicento in Europa erano in uso una varietà e una quantità
incredibili di forme di esecuzione. Nell’antica Roma la
crocifissione era riservata quasi esclusivamente agli schiavi, i
liberi cittadini romani condannati a morte venivano decapitati con la
scure. Alla morte sul rogo, nel Medioevo, venivano destinati gli
agitatori, gli stregoni, le streghe e gli omosessuali. Gli ebrei
venivano appesi per i piedi fra due cani appesi per le zampe
posteriori, che nel terrore dell’agonia sbranavano il condannato.
Alle
diverse forme di esecuzione erano collegate moltissime superstizioni,
dalle quali traspare spesso, secondo Leder, la memoria collettiva dei
sacrifici umani di un tempo. L’usanza di lasciare i cadaveri
esposti sul patibolo fino a quando gli elementi e gli uccelli non ne
avessero fatto sparire ogni traccia non nacque come terrificante
avvertimento e ammonimento per il popolo: Leder osserva come dietro
ad essa si nascondesse il bisogno di offrire i morti, come un tempo
venivano offerte le vittime dei sacrifici umani, alle forze della
natura: agli spiriti del vento e dell’acqua, o ai corvi (spesso
ritenuti uccelli sacri).
Inoltre,
se talvolta succedeva che l’esecuzione non riusciva bene, i
numerosi spettatori si facevano spesso prendere dalla simpatia per il
condannato. Evidentemente, ipotizza Leder, il popolo intuiva
oscuramente che il condannato in realtà non era che una vittima
sacrificale, riconoscendo in lui le proiezioni delle proprie paure e
sensi di colpa. Allo stesso modo anche alcuni condannati avrebbero
intuito le propria funzione di vittima sacrificale, traendo
addirittura «piacere, in una sorta di disperato masochismo», dai
pomposi onori tributati alla loro persona nel cerimoniale solenne
dell’esecuzione. Così, secondo Leder, si spiegherebbe anche il
comportamento di Maria Stuarda. E così tanti condannati avrebbero
avuto la forza di sostenere l’esecuzione e, spesso, anche le
torture che la precedevano.
Fu
solo la Rivoluzione Francese a porre fine alle pratiche medievali. Il
10 ottobre 1789 il medico e deputato Joseph Guillotin presentò una
proposta di legge in cui era prevista un’unica forma di esecuzione
per tutti i ceti e tutti i delitti «capitali». La morte del
condannato, sosteneva il medico, doveva venir provocata mediante un
procedimento «adeguato, uguale per tutti e per quanto possibile
umano».
Il
compito di progettare lo strumento adatto venne assunto da un collega
del dottor Guillotin, il chirurgo Antoine Louis. Questi escogitò la
ghigliottina, prendendo a modello un apparecchio per decapitazione
già in uso nel Medioevo. La costruzione venne affidata a un abile
artigiano: il fabbricante di pianoforti tedesco, a Parigi, Tobias
Schmidt.
Dopo
un’innumerevole serie di prove con cadaveri umani e con pecore
vive, nell'aprile del 1792 l’apparecchio venne utilizzato per la
prima volta per l’esecuzione di una pena capitale.
La
prima vittima fu un rapinatore di nome Pelletier: sotto la macchina
chiamata inizialmente «Louisette», e solo più tardi «Guillotine»,
la sua testa cadde così velocemente e facilmente che gli spettatori,
avidi di orrori, si allontanarono delusi. Il boia di Parigi, invece,
Monsieur Sanson, fu entusiasta della novità. Come la maggior parte
dei suoi colleghi (che in Europa si chiamavan l’un l’altro
«signor cugino»), egli soffriva, oltre che per il duro lavoro con
la scure, soprattutto per il disprezzo che tradizionalmente
circondava il suo lavoro.
Gli
errori sul lavoro, però, il boia era abituato a pagarli cari. Se
combinava qualche guaio, aveva buone probabilità che la folla,
improvvisamente irritata, cercasse di linciarlo. È quindi logico che
i boia collaborassero alla ricerca di una «morte veloce», ricerca
iniziata con l’invenzione della ghigliottina, che ha portato,
nell’America ossessionata dal perfezionismo tecnologico, alla sedia
elettrica, sperimentata per la prima volta nell’agosto del 1890, e
alla camera a gas.
Oggi
però, come fa notare Leder, in tutto il mondo si è diffusa una
forma di esecuzione originariamente riservata ai tribunali militari:
la fucilazione che distribuisce la colpa su diversi esecutori.
Dovunque venga eseguita una condanna a morte, sostiene Leder, torna
anche oggi a farsi evidente il nesso nascosto tra sacrificio umano e
pena di morte.
Leder
ha scritto questo libro perché vuole spiegare le origini e i motivi
della pena di morte, e la vorrebbe vedere bandita, confinata nel
«Museo degli orrori umani», dove le spetta «un posto ad esempio e
ricordo degli abissi di follia da cui l’umanità ha dovuto
faticosamente trarsi fuori». Per Leder la storia della pena di morte
è la «storia delle molte forme di violenza esercitata dalla società
nei confronti del singolo», ed è anche la «storia del cattivo uso
fatto della ragione, troppo spesso prostituita pur di far passare
l’omicidio per una giusta espiazione della colpa».
“L'Europeo”, 21 ottobre 1980
“L'Europeo”, 21 ottobre 1980
Nessun commento:
Posta un commento