E’ scomparso alcune settimane fa Marcello Cini, scienziato di riconosciuto prestigio e uomo di sinistra (era stato tra i fondatori del “manifesto”), a mio avviso assai poco ricordato. In un documentato e polemico articolo del 2002, sulla “rivista del manifesto” diretta da Lucio Magri, Cini ragionava sull’attacco condotto da una parte della comunità scientifica contro l’ambientalismo (spesso definito “fondamentalista”) e degli interessi non solo scientifici che lo muovevano. Mi pare che, nonostante gli anni trascorsi, le cose che Cini scriveva conservino intatto il loro valore. (S.L.L.)
 |
| Marcello Cini |
1.
Negli ultimi trent’anni, con la nascita e lo sviluppo dei movimenti ambientalisti, è andata diffondendosi e consolidandosi nell’opinione pubblica dei paesi industrializzati la coscienza dei pericoli derivanti dalla incontrollata distruzione dell’ecosistema terrestre e della sua biodiversità, dalla vorace dilapidazione delle risorse, dall’incosciente accumulo di rifiuti nell’aria, nell’acqua e nella terra, che minacciano il livello di benessere e la qualità della vita raggiunti dalla civiltà negli ultimi tre secoli. Esempi ormai ben noti di questi pericoli vanno dall’effetto serra, con i mutamenti climatici che ne derivano, all’enorme potenziale distruttivo costituito dalle testate delle armi nucleari accumulate e dalle scorie radioattive delle centrali che nessuno sa come smaltire, dal diffondersi di nuove epidemie prodotte da agenti patogeni di origine sconosciuta ai possibili effetti dannosi dell’immissione nella biosfera di nuovi organismi transgenici incontrollabili.
Lo shock dell’11 settembre ha poi portato alla scoperta dell’estrema fragilità delle società ipertecnologiche e alla messa in evidenza che le radici di questa aberrante e catastrofica forma di attacco al potere economico e militare dell’Occidente affondano nel terreno della crescente esclusione della maggior parte del genere umano dal godimento dei frutti della ricchezza prodotta dal suo meccanismo di sviluppo, una esclusione resa più frustrante e disperata in quanto accompagnata dalla spoliazione delle ricchezze naturali del Sud del mondo da parte del Nord e dalla dissoluzione della trama che, fornendo identità culturale e motivazioni ideali ai suoi membri, teneva insieme il tessuto sociale delle società precapitalistiche. Si comincia dunque a percepire che la nascita dei movimenti di protesta, la consapevolezza dell’accentuarsi delle disuguaglianze fra ricchi e poveri, il moltiplicarsi di reazioni incontrollate di panico ai rischi e ai disastri imprevisti che colpiscono nuovi soggetti, costituiscono una obiettiva minaccia per la stabilità di questa società e colpiscono gli enormi interessi che ne sono coinvolti.
Per reagire a questa minaccia i poteri forti hanno bisogno di una nuova strategia. Fino ad ora, infatti, riconoscendo la fondatezza delle preoccupazioni espresse dal variegato fronte dell’ambientalismo e la legittimità delle sue denunce, i centri del potere economico avevano risposto con una infusione di ottimismo, assicurando che gli strumenti scientifici e tecnologici per risolvere i problemi sollevati erano disponibili o facilmente realizzabili, e investendo capitali nelle industrie del risanamento ambientale e delle nuove tecnologie per l’utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia e del risparmio energetico. Ma con il dilagare del pessimismo, la vecchia strategia non funziona più. Occorre dunque da un lato delegittimare l’ambientalismo, affermando l’infondatezza scientifica delle sue analisi, e dall’altro combatterlo sul terreno morale in nome di un’ideologia forte, trasformandolo in nemico. L’ambientalismo viene fatto diventare, in quest’ottica, un’ideologia fondamentalista, con tutto il carico di associazione simbolica con il Male che questo aggettivo comporta, e antiscientifica.
La nuova strategia mira in sostanza a conquistare il mondo della scienza e a integrarlo nel sistema di potere dominante, proponendo ad esso un ruolo di primo piano all’interno di un modello di sviluppo che bandisce i problemi ambientali dalla sua agenda, dichiarandoli privi di fondamento fattuale e fonte di pericolose instabilità economiche e sociali. Negli Stati Uniti questo cambiamento di strategia inizia nei primi anni ‘90, e si traduce dieci anni dopo nell’adozione da parte di Bush di una serie di misure – la denuncia degli accordi di Kyoto, la ripresa delle perforazioni petrolifere in Alaska, il rifiuto di ratificare gli accordi sulla difesa della biodiversità, e altre ancora – contro l’ambiente.
2.
In Italia la svolta acquista una clamorosa visibilità perché coincide con l’avvento al potere della destra, e con il salto sul carro del vincitore anche di esponenti autorevoli del mondo scientifico. Ho già avuto modo di polemizzare sul «manifesto» con gli autori di ben quattro interventi comparsi sul numero di giugno de «Le Scienze» che attaccano violentemente l’ambientalismo e la sua ideologia definita oscurantista, irrazionale e antiscientifica. Non è un caso che due degli autori, il fisico Renato Ricci e il chimico fisico Franco Battaglia, siano stati immediatamente ricompensati dal nuovo ministro dell’ambiente Matteoli con la nomina rispettivamente a commissario e a presidente del comitato scientifico dell’Agenzia per la Protezione Ambientale. E non è nemmeno un caso che uno dei primi atti del nuovo commissario sia stato quello di ordinare ai suoi funzionari di mandare al macero tutte le copie dei rapporti del World Watch Institute che l’Agenzia aveva contribuito a pubblicare nella passata gestione. Bruciare i libri è una vecchia abitudine della destra.
Una seconda iniziativa del nuovo corso si intitola Manifesto per un nuovo ambientalismo umanista, liberale e cristiano, per una vita buona, promosso, oltre che da alcuni personaggi recentemente convertiti alla destra, anche, purtroppo, da uno scienziato prestigioso come Edoardo Boncinelli. In questo documento si dichiara che l’ambientalismo ha la colpa, tra le molte altre, di negare il fatto che l’uomo sia stato «creato ‘a immagine e somiglianza’ del suo Creatore». È un’affermazione singolare, per scienziati che insegnano come la nostra specie derivi dai primati che 4 o 5 milioni di anni fa scesero dagli alberi della foresta tropicale africana adottando la posizione eretta. A maggior ragione non si capisce come possano sottoscrivere l’affermazione che «negando questa verità, [che l’uomo sia creato a immagine e somiglianza del suo Creatore, n.d.r.] l’ambientalismo riduce la fede a un pastone di superstizioni animistiche, la morale a una serie di prescrizioni biologiche». Ma non era proprio di questo che il vescovo Wilberforce accusava Darwin? La prossima mossa non sarà per caso quella di riconoscere che i creazionisti americani hanno ragione a chiedere che la versione biblica venga insegnata come teoria scientifica insieme all’evoluzionismo darwiniano?
3.
L’impianto teorico del Manifesto per una vita buona inizia con la costruzione di un nemico di comodo da poter demonizzare. La colpa principale del «fanatismo ambientalista» sarebbe infatti quella di farsi portatore di una «ideologia della paura» e di un «continuo e ansiogeno allarmismo». Il suo errore concettuale principale sarebbe quello di «pensare alle risorse come a un’entità determinata» e di immaginare che «il rapporto uomo-natura sia arrivato all’ultimo stadio della sua evoluzione» di modo che «non ci sarebbe che una sola alternativa: o arrendersi, rinunciando a progettare nuove avventure umane, o morire». Di qui nascerebbe «l’opinione che parte rilevante delle applicazioni della scienza andrebbe sospesa finché non vi sia la certezza assoluta che essa non comporti ‘alcun rischio’».
La tecnica adottata è semplice. È facile contrapporre a questi ambientalisti con l’anello al naso l’ottimismo di chi ha fiducia nella «fantasia creatrice e innovatrice dell’uomo e nella sua capacità di farsi carico in prima persona della responsabilità di governare il proprio ambiente». Ma che altro hanno fatto gli ambientalisti (quelli veri, gli unici che meritano questo nome, che da trent’anni si battono per salvare il pianeta dalla distruzione da parte degli amici degli estensori del Manifesto per una vita buona) se non indagare lo stato del pianeta con gli strumenti della razionalità scientifica, arrivando in questo modo a denunciare, per esempio, che non si può violare il secondo principio della termodinamica e dunque che la carrying capacity dell’ecosistema terrestre ha un limite che nessuna ‘iniziativa di individui ingegnosi’ potrà superare? E non è razionale denunciare che nessuna ricerca potrà inventare un modo di smaltire le scorie radioattive con vita media di migliaia di anni che si accumulano nei depositi senza che un giorno o l’altro i nostri pronipoti se le ritrovino nell’acqua da bere? O ancora che nell’ultimo secolo la percentuale di anidride carbonica nell’atmosfera è passata da 300 a 360 parti per milione, con un tasso di crescita cento volte superiore a quello degli ultimi 20.000 anni nel corso dei quali la concentrazione era variata da 180 a 300 ppm, e dunque che se non si fa qualcosa subito per invertire la tendenza si andrà presto incontro a mutamenti climatici catastrofici di origine antropica, che già si intravedono?
4.
Dopo questa premessa gli autori del Manifesto vengono al sodo. Mentre «il fondamentalismo ecologista sogna un ambiente statalizzato dall’alfa all’omega», essi sono convinti che «il dramma dell’inquinamento risieda nell’assenza del riconoscimento di diritti di proprietà sulle risorse ambientali». Questo programma si realizza restituendo «alle istituzioni più vicine ai cittadini le responsabilità per la tutela del territorio». Dunque, niente più «parchi nazionali costruiti a tavolino» ma «federalismo ecologico, che vada a rinsaldare quel rapporto unico e speciale che c’è tra una persona e la terra in cui nasce». Essi chiedono dunque che «i cittadini siano gli unici ad avere diritti sui luoghi in cui sono nati, cresciuti, vissuti» – e credono «che la negazione e l’esproprio di questi diritti corrisponde a un ordine illiberale». Detto più semplicemente, possiamo sintetizzare tutto questo con la parola d’ordine «Dieci, cento, mille Fuenti!». Che altro infatti significa lasciare libero ogni cittadino di trarre il maggior beneficio possibile dal suo pezzo di terra, dal suo scorcio panoramico, dal suo accesso al mare?
Oltre a ‘privatizzare l’ambiente’ la ‘nuova ecologia umanista’ enuncia altri due punti chiave. Il primo suona così: «Fondare le politiche pubbliche per l’ambiente sulla logica del calcolo costi-benefici». Sembra ragionevole. Non si può infatti non essere d’accordo sul principio: «Non è razionale ridurre i rischi arrivando al punto che le risorse necessarie per farlo potrebbero essere più efficacemente utilizzate per migliorare in altro modo la qualità della vita umana o dell’ambiente».
Il problema è tuttavia che sono in genere pochi, ricchi e potenti coloro che godono dei benefici, mentre sono molti, poveri e privi di potere quelli che devono sopportare i costi. Questo è vero sia su scala mondiale che su quella locale. I paesi industrializzati, ad esempio, godono dei benefici derivanti dall’immissione nell’atmosfera di enormi quantità di anidride carbonica, ma gli effetti, sia pure difficilmente quantificabili, delle instabilità climatiche derivanti dall’effetto serra devastano con gli uragani i paesi poveri della fascia tropicale come il Bangla Desh o il Nicaragua, e con la desertificazione quelli dell’Africa settentrionale o dell’Asia centrale. Un discorso analogo si potrebbe fare, ad esempio, per i costi pagati dai cittadini, in termini di danni alla salute e di rischi per incidenti derivanti dall’incentivazione alle industrie che producono beni inquinanti o insufficientemente sicuri, come quelle chimiche o quelle automobilistiche. Come si fanno i conti e soprattutto chi li fa?
5.
Il secondo principio dice: «Promuovere le biotecnologie agroalimentari come applicazioni irrinunciabili per produzioni di qualità, per la conservazione della biodiversità in agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico dei Paesi più poveri e delle aree con condizioni climatiche sfavorevoli».
Questo è un altro punto centrale di tutta l’operazione e ne rivela i mandanti. In questa frase si mescolano infatti le due più spudorate bugie messe in circolazione dalle multinazionali dell’agroalimentare. Che le sementi transgeniche della Monsanto o della Novartis contribuiscano alla conservazione della biodiversità è la versione moderna della favola del lupo e dell’agnello. Queste industrie, e le altre due o tre che si spartiscono il 95% del mercato mondiale, rappresentano in realtà il pericolo maggiore per la salvaguardia della biodiversità delle piante alimentari. Ancorando l’uso delle sementi all’utilizzazione dei diserbanti e dei pesticidi da loro stesse prodotte, esse stanno infatti mettendo fuori mercato la stragrande maggioranza delle varietà naturali, che, una volta scomparse, non potranno mai più essere recuperate. Con la brevettazione, poi il mercato sarà irreversibilmente dominato da un numero di varietà diverse che si può contare sulle dita.
La seconda bugia è che le biotecnologie agroalimentari siano l’irrinunciabile strumento per promuovere lo sviluppo socioeconomico dei paesi più poveri. Che la fame nel mondo non provenga da una carenza di cibo è oggi una verità largamente riconosciuta: l’Occidente si dibatte con gli ‘esuberi’ e l’Unione Europea paga chi si astiene dal produrre. La Deutsche Bank, nel suo rapporto 1999 dice: «Gli Ogm vogliono aumentare la produzione in un mondo che sta annegando nella sovrapproduzione dei cereali». Ancora una volta dunque, i poveri vengono presi in giro. La fame nel mondo non verrà alleviata: essa dipende solo dal fatto che coloro che la patiscono non hanno i soldi per comprare il cibo necessario alla loro sopravvivenza, perché i ricchi non solo non comprano i loro prodotti a prezzi sufficientemente elevati, ma saccheggiano e distruggono le risorse naturali di biodiversità che costituiscono la ricchezza delle regioni tropicali più povere del pianeta.
6.
Una terza manifestazione della nuova strategia, più seria ma forse per questo anche più grave, viene direttamente da alcuni esponenti della comunità scientifica. Si tratta del Manifesto dell’Associazione Galileo 2001. Tra i fondatori figurano Renato Angelo Ricci, e Franco Battaglia, che già conosciamo. Tra i trenta firmatari figurano anche alcuni nomi assai noti del mondo della scienza ‘pura’ – e tra loro ci sono anche persone delle quali ho profonda stima come uomini e come scienziati – ma coloro che si occupano professionalmente di problemi connessi alla salute sono soltanto sette o otto, e quattro sono quelli in qualche modo legati a discipline tecnologiche. Sui temi che hanno un diretto impatto sulla vita della gente, dunque, molti parlano, diciamo così, per sentito dire. L’attacco all’ambientalismo è anche qui diretto.
«Un fantasma si aggira da tempo nel Paese, – leggiamo – un fantasma che sparge allarmi ed evoca catastrofi, terrorizza le persone, addita la scienza e la tecnologia astrattamente intese come nemiche dell’Uomo e della Natura e induce ad atteggiamenti antiscientifici facendo leva su ingiustificate paure che oscurano le vie della ragione. Questo fantasma si chiama oscurantismo. Si manifesta in varie forme, tra cui le più pericolose per contenuto regressivo ed irrazionale sono il fondamentalismo ambientalista e l’opposizione al progresso tecnico-scientifico».
I capi d’accusa comprendono temi già noti, ma anche, come vedremo, qualcuno nuovo che appare francamente singolare. Tra i primi figurano, al solito:
- il timore di cambiamenti climatici che, da milioni di anni caratteristici del pianeta Terra, sono oggi imputati quasi esclusivamente alle attività antropiche;
- le limitazioni alla ricerca biotecnologica che impediscono ai nostri ricercatori di cooperare al raggiungimento di conquiste scientifiche che potrebbero tra l’altro combattere gravi patologie e contribuire ad alleviare i problemi di alimentazione dell’umanità;
- il terrorismo sui rischi sanitari dei campi elettromagnetici, che vuole imporre limiti precauzionali ingiustificati, enormemente più bassi di quelli accreditati dalla comunità scientifica internazionale e adottati in tutti i paesi industriali;
- la preclusione dogmatica dell’energia nucleare, che penalizza il Paese non solo sul piano economico e dello sviluppo, ma anche nel raggiungimento di obiettivi di razionalizzazione e compatibilità ambientale nel sistema energetico.
Dei primi due abbiamo già parlato diffusamente. Stupisce soltanto, in un Gotha scientifico così autorevole, la ripetizione acritica di stereotipi pubblicitari diffusi dalle multinazionali interessate, come se si trattasse di verità indiscusse. Per quanto riguarda il terzo è anzitutto il caso di avvertire gli estensori del documento che dovrebbero andarci piano, di questi tempi, nell’accusare qualcuno di terrorismo. Si dovrebbero vergognare di usare questo termine per attaccare coloro che non condividono il loro ottimismo programmatico, quando di terroristi veri, oltre a quei fanatici disperati che si fanno saltare per aria con le loro vittime innocenti, ce ne sono già altri in giro che pochi osano nominare.
Venendo poi al merito della questione, può anche darsi che sia stato prematuro imporre limiti che potrebbero essere troppo stringenti per questo tipo di emissioni, ma non va dimenticato che gli effetti biologici dei campi estremamente deboli sono ancora tutt’altro che definitivamente chiariti, e che solo oggi si comincia a scoprire che la struttura dell’acqua, componente fondamentale ed essenziale di ogni organismo vivente, mostra una complessità assolutamente imprevista. È comunque vero che esistono per il momento problemi più urgenti e gravi, che richiedono l’investimento prioritario di risorse imponenti, ma si tratta proprio di quelli, come i primi due, che, guarda caso, i nostri galileiani considerano inesistenti o irrilevanti.
Per quanto riguarda infine la quarta accusa si tratta invece di una stanca ripetizione di speranze deluse, vecchie di cinquant’anni – tant’è vero che in nessun paese del mondo industrializzato si costruiscono nuove centrali nucleari – che ignora completamente il vero duplice drammatico problema irrisolto (che è il nucleo dell’opposizione degli ambientalisti all’uso dell’energia nucleare) dello smaltimento delle scorie delle centrali e della distruzione delle testate nucleari militari.
7.
Tre accuse sollevano invece a dir poco un certo stupore. La prima è di fomentare «la ricerca e l’esaltazione acritica di pratiche mediche miracolistiche che sono ritenute affidabili solo perché ‘alternative’ alla medicina scientifica». È un’accusa ridicola. Magari, vien da dire, avessero tanto potere. Perché invece non si discute seriamente di questo problema? Sono convinto, per esempio, che i nostri esagitati galileiani non sanno che l’Istituto Superiore di Sanità ha organizzato tre anni fa un Convegno sulle ‘Medicine non convenzionali’ nel quale sono state pacatamente presentate e discusse pratiche come l’agopuntura, la fitoterapia e persino (orrore!) l’omeopatia.
Certo, nessun ambientalista serio negherebbe gli enormi progressi compiuti dalla medicina ‘convenzionale’ negli ultimi decenni del XX secolo e che hanno contribuito notevolmente a uno spettacolare aumento della durata della vita nei paesi ricchi (in quelli poveri si muore ancora a quarant’anni). Non va dimenticato tuttavia che le ragioni che portano un crescente numero di persone a cercare sollievo ai propri malesseri (somatici, psichici o psicosomatici) al di fuori della medicina ufficiale non sono effetto di un malvagio complotto: non sarebbe il caso che i medici facessero anche un pizzico di autocritica? Non sarà che il modo in cui l’istituzione medica tratta i pazienti – come una officina di riparazione di auto alle quali basta cambiare il pezzo che si è rotto – non è precisamente ciò di cui un malato, che non è un’auto, ha bisogno per guarire, se è possibile, o per affrontare serenamente un male incurabile?
Antonio Damasio, neurofisiologo di fama mondiale, ad esempio, scrive a questo proposito nel suo libro L’Errore di Cartesio che «l’idea di una mente distaccata dal corpo [ha] foggiato il peculiare modo in cui la medicina occidentale affronta lo studio e il trattamento della malattia». E aggiunge: «Una visione distorta dell’organismo umano, insieme con l’esigenza di specializzazioni sempre più spinte, contribuisce ad aggravare l’inadeguatezza della medicina, piuttosto che a ridurla».
La seconda accusa – di volere «il permanere di una condizione di emergenza nel trattamento e nello smaltimento dei rifiuti di ogni tipo» – è invece scandalosa. Chi, se non il movimento ambientalista, si è battuto per anni contro le discariche di veleni che hanno devastato città e campagne del nostro paese, uccidendo centinaia se non migliaia di persone, dall’Acna di Cengio alla Montedison di Porto Marghera, dal Petrolchimico di Brindisi a quello di Augusta? Chi, se non Legambiente impegna ogni giorno migliaia e migliaia dei suoi soci a denunciare discariche abusive, inquinamenti di acque dolci e marine, depuratori mancanti o inoperanti? Chi, se non gli attivisti delle associazioni ecologiste, sono i protagonisti della battaglia per chiudere al traffico automobilistico privato quei centri storici che stanno diventando ogni giorno di più camere a gas, combattendo contro l’ottusa ignoranza di automobilisti col sedere incollato alla macchina, la gretta cecità di commercianti spaventati dal dilagare della grande distribuzione e gli enormi interessi delle industrie automobilistiche e petrolifere?
La lettura delle relazioni della Commissione parlamentare di inchiesta sui rifiuti, presieduta per due legislature dal deputato verde Massimo Scalia, è agghiacciante. Al Nord sono le industrie, gli allevamenti intensivi, le amministrazioni locali che scaricano indisturbati rifiuti tossici, rifiuti urbani non riciclati, schifezze di ogni genere. Al Sud sono mafia, camorra e ndrangheta che gestiscono il lucroso traffico di rifiuti di tutti i generi. Tutta colpa degli ambientalisti? Altro che «soluzioni tecnologiche adottate da decenni in tutti i paesi industriali avanzati»: ma dove vivono i miei illustri colleghi?
La terza accusa infine – di «opporsi sistematicamente ad ogni tentativo di dotare il Paese di infrastrutture vitali per la continuità dello sviluppo e per il miglioramento della qualità della vita della popolazione» – è, a dir poco, assai ambigua e generica. Andiamo a vedere nel concreto, caso per caso, di quali grandi infrastrutture si tratta, e di chi e come le dovrebbe fare. Se gli estensori del documento sono, ad esempio, per il ponte sullo stretto di Messina, si documentino meglio: se ne analizzassero il progetto con lo spirito critico che usano nel loro lavoro di scienziati si convincerebbero che si tratta di un’opera faraonica, la cui realizzazione richiederebbe il superamento di ostacoli geologici, climatici ed economici forse insormontabili, e sarebbe soprattutto uno spreco spropositato di denaro, che potrebbe essere molto più utilmente investito a risolvere gli enormi problemi strutturali delle due regioni interessate. Se invece si tratta dei cantieri delle imprese di proprietà del ministro Lunardi, non si parla di scienza, ma di lucrosi affari privati.
8.
Vorrei concludere con alcune osservazioni che in qualche modo vanno incontro alle preoccupazioni di quegli scienziati di tutto rispetto e persone in buona fede, alcuni dei quali sono oltretutto ben lontani dal simpatizzare per l’ideologia e gli interessi della destra che oggi governa il nostro paese, che hanno firmato questi documenti.
La prima cosa che vorrei dire loro è che il movimento ambientalista, o per lo meno una parte fondamentale di esso, riconosce l’esigenza di dare alla ricerca scientifica un ruolo determinante per affrontare razionalmente ed efficacemente i grandi problemi ecologici che incombono sul nostro futuro. Non siamo luddisti, e pensiamo che la conoscenza del mondo fondata su criteri riconosciuti di razionalità e su regole metodologiche che garantiscano un giudizio oggettivamente fondato della sua validità, sia un patrimonio dell’umanità da difendere e da accrescere. Siamo tuttavia convinti, non per pregiudizio ideologico, ma sulla base di fatti incontrovertibili, che il contesto sociale ed economico in cui la crescita di questa conoscenza avviene oggi è profondamente mutato negli ultimi decenni del secolo appena finito rispetto ai tre secoli precedenti.
Gli elementi che caratterizzano questo mutamento sono, a mio giudizio, essenzialmente tre. Il primo è l’intrecciarsi sempre più stretto dei due momenti in cui tradizionalmente l’intervento umano nei confronti della natura si articolava: quello della conoscenza disinteressata (scienza) attraverso la scoperta dei suoi elementi costitutivi e delle sue leggi e quello della utilizzazione pratica di queste scoperte attraverso l’invenzione (tecnologia). Il secondo elemento è la graduale interpenetrazione tra la sfera propria di queste due attività umane che si occupano di ‘fatti’ e la sfera dei valori che stanno alla base delle norme (etiche e giuridiche) intese a regolare le finalità e i comportamenti degli individui nei loro rapporti privati e nelle loro azioni sociali. Il terzo infine è la crescente invasione di queste sfere, e la loro conseguente subordinazione alle ‘leggi del mercato’, da parte degli interessi economici. Non si possono dunque più usare le vecchie categorie per distinguere le attività dei diversi soggetti che contribuiscono al processo di crescita della conoscenza, e le loro responsabilità relative. Occorre, secondo noi, introdurre almeno due nuove distinzioni.
La prima è quella che deve essere fatta fra ricerca pubblica e ricerca privata, e di conseguenza fra scienziati controllori e scienziati controllati. Diversi sono infatti i diritti e i doveri che spettano agli uni e agli altri. Possiamo infatti ben dire che c’è una differenza fondamentale fra i ricercatori dipendenti o i consulenti di imprese private legati al segreto industriale e gli operatori degli enti pubblici di ricerca che dovrebbero rispondere dei loro programmi alla collettività che li finanzia, o per lo meno concordare con i suoi rappresentanti le scale di priorità da rispettare. Chi può negare che i primi hanno come dovere contrattuale quello di massimizzare i dividendi dei propri azionisti e i secondi, come minimo, dovrebbero attenersi alle norme deontologiche mertoniane dell’universalismo e del comunitarismo?
L’unico controllo efficace di questi ultimi sui primi sarebbe quello di istituire albi professionali separati per chi partecipa allo sviluppo di innovazioni destinate ad essere immesse sul mercato, e chi deve non solo identificare e valutare gli eventuali danni già prodotti o che potrebbero insorgere in futuro, ma anche investigare e prefigurare i diversi scenari (e i relativi gradi di incertezza) che dalla loro diffusione potrebbero a breve, o a lungo termine derivare. Ognuno è libero di stare da una parte o dall’altra, ma deve dirlo.
La seconda discriminante riguarda il brevetto. Fino alla sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti del 1980, che ha concesso il primo brevetto su di un batterio geneticamente modificato, la materia vivente non poteva essere brevettata. Non solo. Si potevano brevettare solo le invenzioni (il risultato dell’ingegno), non le scoperte (ciò che esiste in natura). Nemmeno gli elementi transuranici (come il plutonio) che pure non esistono stabili in natura, sono mai stati brevettati, in quanto sono comunque trasformazioni artificialmente indotte in elementi naturali. A maggior ragione la regola dovrebbe valere per gli organismi geneticamente modificati, dato che si tratta sempre di modificazioni artificiali di organismi naturali. Si è trattato dunque semplicemente di un colpo di mano che ha permesso a un piccolo numero di privati di appropriarsi di beni comuni. È, d’altronde, quello che il capitalismo ha fatto fin dalla sua nascita.
Gli estensori di questi documenti, tutti favorevoli alla brevettabilità di ogni risultato che anche indirettamente potrebbe un giorno condurre a un prodotto da immettere sul mercato, sostengono anche che la scienza, per raggiungere una conoscenza oggettiva, deve essere disinteressata e libera da ogni condizionamento. A rigor di logica, dunque, se fossero coerenti con la loro definizione di scienza, dovrebbero aderire alla campagna degli ambientalisti per l’abolizione della brevettabilità degli organismi viventi. Non sembra infatti esserci altro modo per liberare la ricerca disinteressata, motivata dalla curiosità di capire come è fatto il mondo – un ideale che gli scienziati, a mio giudizio giustamente, rivendicano come proprio diritto-dovere – dai lacci che la costringono a seguire strade tracciate con il fine di produrre qualcosa che possa immediatamente trasformarsi in profitto.
“la rivista del manifesto” n.26, marzo 2002
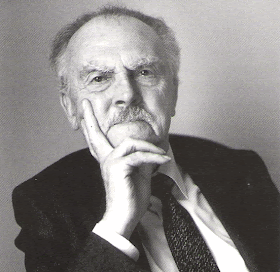


.jpg)





