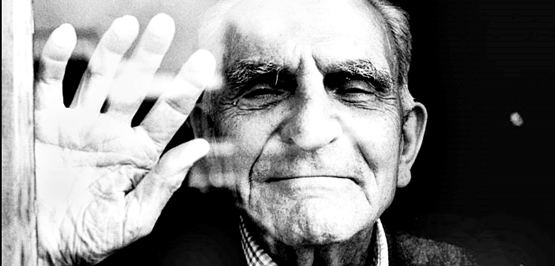|
| Federico Zuccari, Giudizio Universale (part.) - Firenze, S.Maria del Fiore |
Torre dei Passeri -
Questa volta la Casa di Dante in Abruzzo, che ormai da molti anni
dedica mostre al rapporto fra artisti e Dante nelle sale del
suggestivo castello di Torre de' Passeri (memorabili quelle di
Fussli, di Blake, di Botticelli, di Raffaello per non restare che a
pochi esempi), ha scelto un artista non molto noto al di fuori della
ristretta cerchia degli specialisti. Si tratta di Federico Zuccari
(Sant'Angelo in Vado 1540-41 - Ancona 1609), pittore, architetto,
trattatista, scrittore d'arte ed estroso fratello di Taddeo
(1529-1566), di cui è allievo e col quale molte volte lavora. Il
rapporto tra i due è segnato, da parte del più giovane Federico,
che sogna di rendersi autonomo, da un misto di impertinenza e di
devozione.
Siamo in epoca di tardo
manierismo, termine che Corrado Gizzi, ideatore e infaticabile
curatore delle esposizioni di Torre de' Passeri, sottilmente
considera un "interludio platonico", tra razionalità e
fantasia, tra bellezza naturale e bellezza immaginata (era stato
proprio Michelangelo a parlare di "disegno interno", di
"forma spirituale"); e Federico, nel libro Idea de'
pittori, scultori e architetti che pubblica a Torino l'anno 1607,
tratterà appunto di "disegno interno" e "disegno
esterno". Federico Zuccari è un inquieto, un assetato di
sapere, un viaggiatore: visita città e soggiorna nelle corti di
mezza Europa, scrive, prende appunti, esperimenta, disegna. Tra le
sue opere più note: Il Barbarossa prostrato davanti al papa
(Venezia, Palazzo Ducale), Adorazione dei Magi e Adorazione
dei pastori (Spagna, Escorial), Flagellazione di Cristo
(Roma, Santa Lucia del Gonfalone). A Firenze, Federico Zuccari
completa il Giudizio Universale, iniziato dal Vasari per
l'intradosso della cupola della cattedrale di Santa Maria del Fiore
(1575-1579). Ed è forse qui, e in questi anni, che gli viene l'idea
di Dante.
Le parti del poema
Il poeta diventerà per
Federico una specie di emblema: non tanto nel senso di una figura che
simboleggia qualche cosa, quanto invece nell'accezione etimologica,
dal greco "emballo" (getto dentro). Dante rimane infatti in
Federico come un incastro da cui non si può distogliere, come un
elemento di rivelazione. Ci ripensa alcuni anni dopo quando, durante
un suo soggiorno in Spagna (1585-1588), realizza una serie di
illustrazioni della Divina Commedia: ottantotto disegni che,
rilegati in volume, vennero dopo varie vicende in possesso di Anna
Luisa de' Medici che, nel 1738, li donò alla Galleria degli Uffizi
alla quale appartengono; ed ora sono esposti per la prima volta nel
nostro secolo: ecco la mostra. I disegni relativi alla prima cantica
sono eseguiti con matita rossa e nera; quelli del Purgatorio, in gran
parte con penna e bistro; quelli del Paradiso Terrestre e del
Paradiso, con sola matita rossa. Ma non è solo la tecnica del mezzo
a distinguere le parti del poema. Per ogni cantica, Federico cambia
impostazione di spazi e di figure e, soprattutto, di luce. Cerca cioè
di rappresentare ogni volta, come mi suggerisce lo studioso Claudio
Strinati, una luce-utopia, una sorta di luce che, quando la incontri
e la vedi, non è più nulla (e chi non si rammenta delle superbe
acrobazie di Dante nel descriverla? O sviene o s'addormenta o non
vede e ne è comunque e sempre misteriosamente abbagliato).
Nel riquadro delle
illustrazioni Federico inserisce spesso, per iscritto, interi brani
della Divina Commedia che, nella relazione tra spazio ed
episodio, costituiscono un elemento forse di sottolinea, ma che non
esce mai dalla perfezione del ritmo figurativo: lo scritto diventa
grafica, diventa effigie. A volte spazi incombenti, oppressi da rupi,
da caverne, animati da tratti, da penombre; a volte spazi liberi,
astratti, cadenzati da inattese architetture. Se lo spazio, com'è da
credersi, esprime in questi disegni il problema fra realtà e
immaginazione di essa, le figure che vi sono inserite nel significato
dell' episodio (nuvole, alberi, fuoco, piogge, fumo) diventano
zigomi, sagome, arabeschi, nudità perfette ed esortanti, orride,
anelanti, spirituali, corrotte: contraddizione dannata della vicenda
quotidiana; un enigma che il segno stesso di Federico, sinuoso,
raffaellesco, trasmette con insolito fervore. Egli infatti non
illustra Dante per sé, a vantaggio della propria arte, ma legge
Dante perché il poeta è entrato in lui: come d'altronde già si può
avvertire nelle scene infernali della fascia più bassa della cupola
del duomo di Firenze.
Contemporaneo in
ogni epoca
Altre opere esposte a
Torre de' Passeri costituiscono una sorta di prefazione ai disegni
della Divina Commedia: tre dipinti sul tema della "Pietà"
- uno di Taddeo, due di Federico - e, di quest' ultimo, un San
Pietro liberato dal carcere da Raffaello. Ci sono poi, di
Federico, alcuni disegni di vario soggetto e d'una limpidezza e
invenzione veramente avvincenti. Basti rammentare Morte del
primogenito (dove la luce s' insinua in una misteriosa penombra)
e Donna con bambino in braccio inginocchiata all' altare (si
noti il velo e il mirabile scorcio dell' infante).
"Federico svolse -
come ha scritto Luigi Serra - un'attività anche più brillante di
quella del fratello. Egli avviò le formule manieristiche alla luce
dell'arte del Veronese e dei Bassano. Le sue composizioni hanno una
salda e chiara architettura... rivelano inoltre brio decorativo,
senso di misura, talvolta gusto della tavolozza". Ma questa
rassegna, seguendo la tradizione, documenta la sua passione per
Dante; e ne vien fuori un Federico ancora più profondo. È curioso
notare come l'Alighieri riesca ad essere contemporaneo in ogni epoca.
Se non sbaglio anche Mario Luzi, nel corso d'una recente intervista,
ebbe a dire che Dante è il più grande poeta contemporaneo di oggi.
In questo senso la congiunzione, che ogni volta a Torre de' Passeri
unisce il nome dell'artista a quello del poeta, sembra quasi un
celato e arguto ammonimento.
“la Repubblica”, 31
ottobre 1993