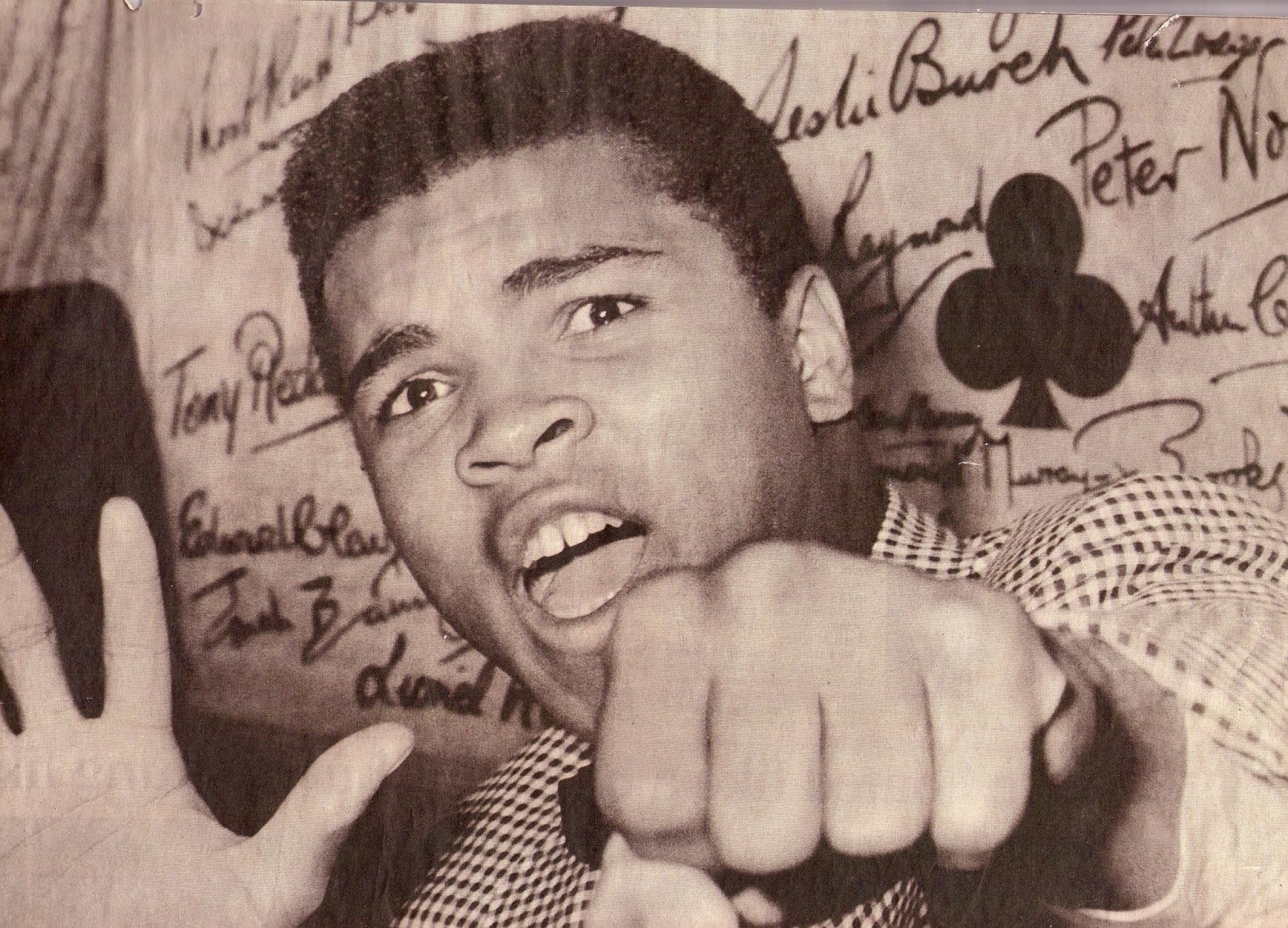Sarà pur vero che Tommaso
Landolfi «si specchia» in questi due racconti di Cechov, come recita il retro
di copertina del volumetto uscito nella «Minima» Adelphi (La lettura. Kastanka, nota di Giovanni Maccari, pp. 72, euro 6). Ma
è uno specchiarsi meno quieto di quel che sembri, anche astraendo dal fatto che
(parole sue) «per me il tradurre o appena il rileggere un qualunque scrittore è
rendermelo come dire avverso»; a pelle, si potrebbe aggiungere recependo il
successivo paragone landolfiano con le gigantesse di Gulliver.
Dopo il Dostoevskij del
sottosuolo, Tolstoj e Turgenev, già riapparsi da Adelphi, ecco ulteriori disjecta membra dall'antologia Narratori russi proposta a Landolfi da
Elio Vittorini per l'editore Bompiani e uscita nel 1948. Landolfi traduttore
veniva dai Racconti di Pietroburgo,
che gli avevano fruttato anche una polemica con Vitaliano Brancati sulla
curvatura antirealistica impressa a Gogol', e da scrittore nutriva da sempre
ammirazione per i russi: tanto modelli di stile comportamentale (nottivago,
ozioso, dissipatore) quanto suscitatori in letteratura di un'indocile libertà
di fronte al reale: visto non come un dato pacifico sancito in via univoca dal
senso comune, ma quale estensione indefinita di possibilità da cui far
scaturire l'eccezione che apre le porte dell'universale. Solo ricreando ogni
volta se stessa e le proprie condizioni, la scrittura, come quella del
prediletto Dostoevskij, potrà essere un'arte del possibile, convogliando nella
propria energia l'abbandono al caso e a un errore necessario, ma anche una
paradossale fiducia in un senso a venire.
A Cechov, «alquanto enigmatico per costituzione», Landolfi dedicherà negli anni '50, sulle pagine del «Mondo», ben cinque articoli e recensioni (poi raccolti in Gogol' a Roma) mettendone in luce l'indifferenza ai proclami e la renitenza alle prese di posizione immediatamente utilizzabili: «Cechov ci racconta e dice tante cose, e anzi in forma piana, suasiva, irresistibile, tuttavia non ci comunica né intende comunicarci nulla», poi per giunta «si guarda bene dal trarre conclusioni finali». E quel grande romanzo che soffrì di non aver scritto è in realtà la sua intera opera, in tutti i minuzzoli sparsi che gettano uno sguardo sul mondo composito come quello di un insetto (chissà che anche qui Landolfi non stesse pensando in parte a se stesso).
A Cechov, «alquanto enigmatico per costituzione», Landolfi dedicherà negli anni '50, sulle pagine del «Mondo», ben cinque articoli e recensioni (poi raccolti in Gogol' a Roma) mettendone in luce l'indifferenza ai proclami e la renitenza alle prese di posizione immediatamente utilizzabili: «Cechov ci racconta e dice tante cose, e anzi in forma piana, suasiva, irresistibile, tuttavia non ci comunica né intende comunicarci nulla», poi per giunta «si guarda bene dal trarre conclusioni finali». E quel grande romanzo che soffrì di non aver scritto è in realtà la sua intera opera, in tutti i minuzzoli sparsi che gettano uno sguardo sul mondo composito come quello di un insetto (chissà che anche qui Landolfi non stesse pensando in parte a se stesso).
Malgrado il riserbo, malgrado il
rifiuto di esaurirsi in una posizione dichiarativa, Cechov a parere di Landolfi
«tutto quel che gli stava a cuore lo disse». E la sua vita va osservata come un
mistero in piena luce, mediante la stessa via negativa che si riserva a un
altro grande nato «sotto altra stella», quel Poe in cui il raziocinio non ha
fatto che aggiungere potenza alla visione.
Narratore «prestigioso» e imprendibile, traduttore d'eccezione, cosa ritrova, se qualcosa intende ritrovare, Landolfi in questo Cechov giovanile? Il primo testo, nello schizzare gli esiti calamitosi della lettura di romanzi fra un gruppo di impiegati, rovescia nel comico le tendenze edificanti che vedevano nella diffusione della lettura un segno di progresso, e si può dire che nel suo estro bozzettistico, condizionato negli spazi e nei toni dalle costrizioni giornalistiche, ci sia qualche sintonia con aspetti dell'opera del conte giocatore, clown admirable del nostro '900: si pensi a certe scene con fumo di parodia della Pietra lunare o ad alcune pagine più feriali di Ombre.
Di qui parte per Landolfi una direttrice che sigla l'imperterrito stile di chi si sentì sempre lontano dal marciare alle parole d'ordine del presente. Mentre i temi inscenati da Cechov nella storia della cagna Kastanka, che si perde per le vie del mondo scoprendo esperienze e personaggi con suprema freschezza di sguardo, riporta, come segnala l'ottimo Maccari, a quella Favola che chiude la raccolta Il Mar delle Blatte: ma con una virata metafisica, di allegoria inconclusa, laddove l'autore russo si attesta sull'aneddotico nel segno di una calda tenerezza. E non serve ricordare l'importanza assunta da un bestiario quanto mai polimorfo (dai cani ai ragni, ad altri «animalini») in un'opera tra le più magnetiche della nostra letteratura. In una borgesiana coincidenza a ritroso, in cui lo scrittore italiano quasi crea il proprio predecessore, il curatore evidenzia tra una lettera di Cechov e un eccelso racconto landolfiano, La beccaccia, una situazione esattamente parallela: dove lo sguardo non si sa se implorante o alieno dell'animale che non riesce a morire scatena una tensione lancinante.
Come la scrittura è affetta da «mal di vuoto», la traduzione vive di per sé di insufficienza: «che farci», scriverà altrove Landolfi, «se la poesia è cosa tanto universale da restare in larga misura avvinta alle particolarità di una lingua?». Non è il solo caso in cui l'impossibile si configuri come per ciò stesso necessario. Più che interrogarsi su agonismo o discepolato nel cimento traduttivo, non va trascurato (e Maccari lo sottolinea) che forse Cechov rappresentava per Landolfi una possibilità di vivere e di essere scrittore, per via dell'«estrema pulizia della sua posizione artistica», assorbita solo dalla verità poetica del proprio fare, intrinsecamente morale.
Narratore «prestigioso» e imprendibile, traduttore d'eccezione, cosa ritrova, se qualcosa intende ritrovare, Landolfi in questo Cechov giovanile? Il primo testo, nello schizzare gli esiti calamitosi della lettura di romanzi fra un gruppo di impiegati, rovescia nel comico le tendenze edificanti che vedevano nella diffusione della lettura un segno di progresso, e si può dire che nel suo estro bozzettistico, condizionato negli spazi e nei toni dalle costrizioni giornalistiche, ci sia qualche sintonia con aspetti dell'opera del conte giocatore, clown admirable del nostro '900: si pensi a certe scene con fumo di parodia della Pietra lunare o ad alcune pagine più feriali di Ombre.
Di qui parte per Landolfi una direttrice che sigla l'imperterrito stile di chi si sentì sempre lontano dal marciare alle parole d'ordine del presente. Mentre i temi inscenati da Cechov nella storia della cagna Kastanka, che si perde per le vie del mondo scoprendo esperienze e personaggi con suprema freschezza di sguardo, riporta, come segnala l'ottimo Maccari, a quella Favola che chiude la raccolta Il Mar delle Blatte: ma con una virata metafisica, di allegoria inconclusa, laddove l'autore russo si attesta sull'aneddotico nel segno di una calda tenerezza. E non serve ricordare l'importanza assunta da un bestiario quanto mai polimorfo (dai cani ai ragni, ad altri «animalini») in un'opera tra le più magnetiche della nostra letteratura. In una borgesiana coincidenza a ritroso, in cui lo scrittore italiano quasi crea il proprio predecessore, il curatore evidenzia tra una lettera di Cechov e un eccelso racconto landolfiano, La beccaccia, una situazione esattamente parallela: dove lo sguardo non si sa se implorante o alieno dell'animale che non riesce a morire scatena una tensione lancinante.
Come la scrittura è affetta da «mal di vuoto», la traduzione vive di per sé di insufficienza: «che farci», scriverà altrove Landolfi, «se la poesia è cosa tanto universale da restare in larga misura avvinta alle particolarità di una lingua?». Non è il solo caso in cui l'impossibile si configuri come per ciò stesso necessario. Più che interrogarsi su agonismo o discepolato nel cimento traduttivo, non va trascurato (e Maccari lo sottolinea) che forse Cechov rappresentava per Landolfi una possibilità di vivere e di essere scrittore, per via dell'«estrema pulizia della sua posizione artistica», assorbita solo dalla verità poetica del proprio fare, intrinsecamente morale.
Quanto alla
lezione che di quell'esperienza permane viva, sarebbe riduttivo identificarla
nel torcere il collo al realismo. È stato Landolfi stesso, in quella
straordinaria soglia indiretta che è la sua introduzione a Narratori russi, a dirci che quegli scrittori hanno avuto il
coraggio di guardare i fantasmi ridicoli o minacciosi del reale nei loro volti
senza volto (…)
“il
manifesto”, 11 agosto 2012