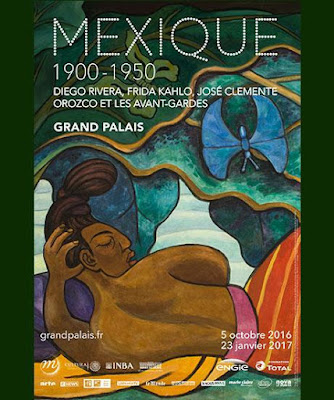È questo il testo —
recuperato da una registrazione fortunosa e pubblicato da “Il
Ponte” nel 2009 — dell’ultima lezione, tenuta dall’autore,
nella Facoltà di Lettere di Firenze, al momento dell’andata fuori
ruolo. (S.L.L.)
 |
| Cesare Luporini a un Congresso del PCI |
Vi ringrazio d’essere
venuti.
Vorrei parlarvi di alcune
cose un po’ remote che mi sono occorse, e anche, anzi soprattutto,
di un tempo remoto: gli anni trenta. La mia generazione intellettuale
ha testimoniato poco, tranne i politici. Forse proprio perché hanno
testimoniato molto i politici, noi ne siamo rimasti un po’
intimiditi. Un amico mi diceva l’altro giorno che la generazione
immediatamente successiva alla mia, invece, ha testimoniato anche
troppo (non so se sia vero).
Comunque, io ho avuto
allora, negli anni trenta, rapporto diretto, per me non irrilevante,
con alcuni uomini non irrilevanti nel campo della filosofia. Faccio
quattro nomi: Gentile, Croce, Heidegger, Nicolai Hartmann. Però ho
la sensazione che falserei tutto, se mi limitassi al campo della
filosofia.
Naturalmente, non ho
intenzione d’intrattenervi sulla mia infanzia. Dirò solo che ho
avuto un’educazione cattolica, anche se molto libera. Dalle mie
famiglie confluivano tradizioni cattoliche, d’un certo tipo, un po’
ereticali, tradizioni laiche e tradizioni socialiste; quindi
contraddittorie fra di loro, e allora molto contraddittorie. A
tredici anni, quando facevo il Ginnasio, ero diventato materialista,
in senso biologico. Dio era un’ipotesi senza senso. E allora trovai
un poeta – Leopardi – che anche nel seguito è poi rimasto sempre
il mio poeta. Ricordo che all’esame di quinta ginnasio (che era
stato introdotto dalla Riforma Gentile) portai proprio Leopardi. Al
Liceo, invece, divenni idealista, anche per effetto d’un grande
insegnante, Giacomo Vertova, che poi lasciò presto l’insegnamento.
Così, in qualche modo arrivai all’università un po’ preformato,
o “pregiudicato”. All’università, ho studiato e mi sono
laureato in questa Facoltà, che, molti anni dopo, m’ha fatto
l’onore di chiamarmi, e così vi ho insegnato questi ultimi
vent’anni. Mi sono laureato con Lamanna, col quale già al primo
anno, mi ricordo, avevo fatto un’esercitazione, per me non poco
impegnativa, su Platone (ma ero già in rapporto con Giorgio
Pasquali). E a Lamanna sono grato soprattutto della completa libertà
che mi lasciò nel mio lavoro per la tesi di laurea.
Questa fu su Kant; ma mi
laureai in Lettere, non in Filosofia, perché, venendo qui studente,
nel 1927, m’ero diretto su altri studi che non quelli filosofici:
piuttosto su studi storici e filologici; anche se pur per ragioni
filosofiche, e cioè per l’idea crociana che facesse bene, prima di
fare il filosofo, d’occuparsi di altre cose; ma anche – devo
dirlo apertamente – per una certa non fiducia, propriamente, nella
“Filosofia” di questa Facoltà. A differenza di Garin, mio
coetaneo, ma che era un anno avanti – e che già allora
consideravamo di gran lunga il più maturo di noi – io non avevo
capito quanto si potesse imparare da Limentani. Lo capii solo il
giorno della discussione della mia tesi di laurea. Mi pentii di non
averlo frequentato, prima, se non molto poco; e da allora in poi
presi ad andare a casa sua, mi ricordo, molto di frequente. Poi,
avrei occupato quella che era stata la sua cattedra – «Filosofia
morale» – allorché la Facoltà volle ricostituirla per me.
Durante gli anni
universitari, dunque, i miei maestri furono altri. Soprattutto
Pasquali, che per me non fu soltanto maestro di storia. A lui debbo
molto. Se ho imparato, per esempio, a fare il “seminario”, lo
devo prima di tutto a lui (e poi, devo aggiungere subito, a
Heidegger). Professori non si nasce; almeno, non so se ci sia
qualcuno che sia nato professore (può anche darsi; ma in generale
credo di no). Io avrei potuto avere una vita diversa; mentre non
riesco a immaginarla senza due cose: senza la filosofia e senza la
politica; e non dico d’essere riuscito a mandarle insieme sempre
bene, ma sono sue lati essenziali, determinanti, per me, e fortemente
intrecciati.
D’essere diventato
professore, in certo modo non ho finito di stupirmi, stupirmi
d’essere da quest’altra parte della cattedra. E fare il
professore è stata per me un’opzione forte, e non fatta una volta
sola, perché ho avuto altre alternative. Anche in momenti un po’
difficili, per me, della cosiddetta carriera accademica, mi sono
ostinato in questa scelta. Quanto al fascismo (nel 1922 – marcia su
Roma – avevo tredici anni), se devo dire di un’impressione
d’allora, soggettiva, parlerei d’una mutilazione della politica,
dell’impossibilità cioè di parteciparvi decentemente, con tutte
le conseguenze: separazione dal popolo, ecc.; e per questo, già
allora, subito, accumulai un rancore, verso il fascismo. È questa
impressione d’insieme che ancora serbo degli anni venti, più che
non di un’oppressione intellettuale e culturale. C’era, cioè, la
possibilità di svolgersi, di formarsi, ma su un lato solo.
Credo anche che a questa
impressione corrispondano dei dati oggettivi. Sanno tutti che il
fascismo, come regime, ha avuto fasi diverse, anche con un prevalere
di personale diverso ai posti di comando; e a questo corrispondevano
climi morali diversi. Ci fu chi – della generazione precedente alla
mia, ma anche della mia – fu capace di reagire molto presto
politicamente. Invece, il mio cammino fu più lento, allora. Vorrei
evocare un attimo cos’era Firenze tra gli anni venti e trenta: una
specie di salotto, pochissime automobili, molte biciclette, molto
spazio per passeggiare, molti stranieri, intendo stranieri residenti
qui, con i quali avveniva d’avere un rapporto. E anche ciò
facilitava un atteggiamento, di distacco dal regime, un po’
snobistico, dopo le prime delusioni che poteva averne avuto uno della
mia generazione. Io partecipai allora d’un tale atteggiamento.
Il cambiamento avvenne,
per me, un giorno del maggio del 1930 – una giornata stupenda,
trasparente, come quelle che abbiamo avuto anche in questa settimana
– allorché ascoltai un discorso di Benito Mussolini. Aveva fatto
un discorso (come venivano chiamati allora i comizi) a Livorno, un
altro a Lucca, e poi venne a Firenze. E io andai a sentirlo (come
privato cittadino, devo dire, e non in qualche organizzazione). Ero,
in Piazza Signoria, in quell’angolo un cui c’è il caffè
Rivoire, dove la folla era un po’ più rada; e mi ricordo benissimo
la scena: dietro di me, un frataccio entusiasta, e poi una signora,
che s’era sentita male, fu portata lì perché respirasse… Il
discorso di Mussolini aveva un tono molto acceso, infiammato: parlava
dell’avanzare dell’Italia come un siluro, un bolide, e così via,
con tutto il resto immaginabile (ma, qui a Firenze, parlò anche, mi
ricordo, del «profeta disarmato»). Ebbene, fu allora che io capii
che bisognava uscire da quell’atteggiamento che ho detto
snobistico. Di lì inizia il mio lungo – lungo – viaggio
nell’antifascismo (il povero Zangrandi ha scritto Il lungo
viaggio attraverso il fascismo; per me, parlerei appunto d’un
lungo viaggio nell’antifascismo).
A metà degli anni
trenta, ero già in una rete, non propriamente, ancora, cospirativa,
ma che lo sarebbe diventata. Era il momento della guerra d’Etiopia;
e mi ricordo, fra tutto il resto, della nostra preoccupazione che
Benedetto Croce aderisse a essa (non al fascismo, ma alla guerra in
corso). Si diceva che andava al porto di Napoli a vedere le truppe
che partivano; e comunque un appoggio a quella guerra sarebbe
rientrato abbastanza coerentemente in tutto il suo modo di vedere la
storia d’Italia. Mi ricordo che si diceva: chi può, vada a Napoli
a trattenerlo per la giacca. Un po’ dopo, questi gruppi, in cui ero
già entrato, diventarono “liberalsocialisti”: Capitini,
Calogero; a Firenze, Enzo Enriques, Tristano Codignola, Ramat;
Bobbio, che allora era incaricato a Siena; e tanti altri. Nel 1942,
confluiranno nel Partito d’Azione; ma Bianchi Bandinelli e io non
vi entrammo: non eravamo d’accordo che quel movimento si
trasformasse in Partito. Poi, nell’agosto del 1943 – quando ormai
tutto precipitava – aderii al Partito comunista, con il quale ero
entrato in rapporto da alcuni mesi. Ricordo che, come usava allora,
per l’ammissione subii un esame, in una vecchia casa popolare di
Pisa; ed ero molto emozionato.
Dopo quel giorno del
maggio 1930 di cui ho parlato, il primo problema che mi si presentò
fu come orientare il mio studio, in vista della tesi di laurea. Ma
anche qui devo accennare al quadro complessivo. In Italia, non c’era
solo la dittatura fascista. C’era anche il predominio
dell’idealismo, che si distingueva nei due grandi nomi: Croce e
Gentile; ed era estremamente avviluppante, intricante. “Croce e
Gentile”, “Croce o Gentile”: questi erano i termini in cui si
dibatteva. Il dissenso politico fra loro dopo il 1925 (il fascismo
l’avevano appoggiato entrambi, ma poi Croce se n’era distaccato)
era solo un lato della questione, non la ricopriva tutta. Per dire
sinteticamente come sentivamo allora: dall’“atto puro” o
dall’identità di teoria e prassi, sostenuti da Gentile, non si
passava necessariamente allo “Stato etico”; sembrava che ci
potessero essere altre scelte, e anche in senso rivoluzionario
(questo, non soltanto per noi; era stato così, per esempio, per il
Togliatti giovane, e lo sarebbe stato, poi, ancora per Lelio Basso,
ai tempi di «Quarto Stato»). Dall’altra parte, dai “distinti”
crociani non si passava necessariamente a un liberalismo
antifascista. A molti sembrava poi che filosoficamente le due
posizioni, di Gentile e di Croce, fossero da conciliare, così anche
sorpassandole. Intanto, però, era Croce a dominare la cultura –
soprattutto quella non strettamente filosofica, ma storica ed
estetica – e, rispetto al fascismo, questo era un bel paradosso. In
certi ambienti culturali c’era anche la convinzione che l’idealismo
italiano, nel suo insieme, fosse comunque in grado di mettere in
scacco qualunque altra posizione filosofica, passata, presente e
futura; cioè la convinzione che eravamo alla testa del movimento
mondiale – e, guardate, sarebbe venuto poi alla luce che anche
Gramsci in fondo partecipava di quest’idea.
Mi ricordo d’averne
discusso, più tardi, rispettosamente, ma vivacemente, con Luigi
Russo. Gli dicevo che “essere in testa” significa avere qualcuno
dietro; mentre invece il movimento mondiale era andato per altre
strade. D’altro canto, sapevamo bene che in Italia l’idealismo
s’era costituito, al principio del secolo, come superamento non
solo del positivismo, ma anche del marxismo; in due versioni diverse,
ma che i lori due autori, appunto Croce e Gentile, avevano
considerato complementari.
Mi è stato chiesto, per
esempio da La Penna, come io sarei passato – molto dopo, fra guerra
e dopoguerra – dall’esistenzialismo al marxismo. Ma credo che a
questa domanda non sia difficile rispondere. Qui vorrei dire
piuttosto come ero passato, prima, all’esistenzialismo. Ebbene vi
passai per effetto di un’esperienza, fallimentare, ma che in
qualche modo può avere un certo significato per ricostruire quel
periodo. Ritorno così ai miei anni universitari, nella prospettiva
della tesi di laurea. Ne tentai infatti una in storia medievale, con
Nicola Ottokar, che era un incaricato, ma di grande fascino come
insegnante, con angolature diverse dalle nostre, italiane,
tradizionali. Una tesi di laurea sopra le societates populi
all’inizio del Trecento a Firenze, che avrebbe dovuto essere lo
sviluppo di un’esercitazione a cui avevo dedicato molto impegno
(m’ero anche messo a frugare negli archivi, dopo aver studiato le
tecniche necessarie a leggere dei documenti medievali). Avevo un
assunto incredibilmente ambizioso: di ritrovare in quell’ambito la
lotta di classe, che il libro di Ottokar uscito nel 1926, Il
Comune di Firenze, in qualche modo sembrava cancellare; cioè di
ritrovare le tesi del Salvemini giovane nel suo Magnati e popolani
(quando ero arrivato all’università, Salvemini non c’era più,
ma c’era ancora una traccia di lui in studenti più anziani;
ricordo, per esempio, le sorelle Nordio, una delle quali avrebbe poi
sposato un illustre slavista).
Devo dire che quella mia
ambizione non era determinata tanto dal libro di Ottokar, quanto
dalla recensione che gli aveva fatto Croce, nella «Critica». Una
recensione di grande esaltazione, ma dove si vedeva che a Croce poco
importava la storia medievale, gli importava invece di mettere da
parte la lotta di classe; e difatti tutta la sua polemica era verso
la scuola economico-giuridica e verso il materialismo storico. A
rileggerla oggi (l’ho riletta proprio in vista di questa lezione),
dopo cinquant’anni, è veramente impressionante. La strada che
allora avevo intrapreso non era dunque quella d’un qualche
crocianesimo, magari pure “di sinistra”, come fu invece per tanti
altri. Ma in quel mio proposito fallii completamente.
Non so dire oggi la
debolezza di quello che poteva essere il mio marxismo d’allora
(avevo sui vent’anni). Non avevo capito quasi nulla, devo
riconoscere, di Antonio Labriola, che mi era rimasto sigillato.
Fallii completamente, dunque; e abbandonai il campo. Però ne ebbi un
trauma molto forte. La conclusione era che il marxismo era bello, ma
non vero. L’altra conclusione, che il lavoro dello storico era
inutile: si vanno a vedere i documenti, ma poi le cose non tornano. E
così passai alla filosofia, non potevo più evitarla; ma sotto una
sollecitazione per la quale il quadro dell’idealismo non bastava:
se il marxismo non era vero, questo significava che, anche per capire
la società, bisognava riconfermare l’individuo come centro
d’iniziativa irriducibile; mentre proprio questa questione,
dell’individuo, ci appariva il punto debole dell’idealismo. In
questo, l’individuo scompariva: nello Stato etico di Gentile oppure
nella “morale dell’opera” del Croce; ma comunque scompariva.
Quella mia d’allora era
una spinta (che oggi potremmo anche dire libertaria) legata all’idea
della finitezza umana, nella sua irriducibilità. Per questa esigenza
– della finitezza umana, dell’iniziativa individuale, della
libertà, e d’una ricostruzione su una tale base anche del rapporto
sociale – mi rivolsi verso Heidegger. Nel ’30 andai in Germania,
a Friburgo, dove insegnava; ma non riuscii a incontrarlo, avevo
sbagliato i tempi. Invece, l’anno dopo (ma ero ancora studente)
entrai nel suo seminario del semestre estivo. L’uomo era di grande
fascino, un fascino, direi, enigmatico; ma anche di un’enigmatica
affabilità – qualcuno diceva che affabile lo era soprattutto con
gli studenti stranieri – e io riuscii a entrare in rapporto con lui
molto rapidamente (venendo da Firenze, era più facile; perché anche
a Firenze s’entrava in rapporto con i professori – con alcuni
professori, ancora una volta, innanzitutto con Pasquali – senza
sfacciataggine ma nemmeno timidezza). Se dovessi dire che cosa ho
preso da Heidegger, direi, in sostanza, quello che invece lui avrebbe
poi respinto, e cioè, precisamente, l’esistenzialismo; mentre mi
sembra d’aver preso pochissimo del suo ontologismo, che già c’era
nel suo libro Sein und Zeit. E devo dire che la ripugnanza
verso l’ontologismo m’è ritornata proprio adesso, e non solo
verso quello di Heidegger, ma in generale, verso tutto
quell’ontologismo che oggi è in circolazione, mi pare, magari
anche sotto vesti politiche (le tante parole con la maiuscola, come
“il Sociale”, “il Politico”, ecc.). Mi ricordo che una volta
dissi, a Heidegger: «Ma in alcune lingue il verbo essere non c’è.
E perché allora costruire tutto intorno a esso?» – e lui si stupì
di quest’osservazione.
Forte fu il trauma per
l’adesione di Heidegger al nazismo. Nel semestre estivo del 1933
ero tornato a Friburgo, con una specie di borsa di studio – nel
frattempo, m’ero laureato, e nella tesi, su Kant, avevo tenuto
conto anche di Heidegger. E così sono fra i pochi stranieri ancora
vivi (credo che ce ne sia un altro in Francia) presenti allora alla
famosa prolusione Die Selstbehauptung der deutschen Universität.
Fu un grosso colpo, per parecchi, particolarmente per gli stranieri,
che erano poi soprattutto dell’Europa centrale. Quanto a me, dopo
una settimana andai da Heidegger, a prendere congedo (il pretesto era
facile, perché, con le sue mansioni di rettore, aveva sospeso il
seminario).
Allora, mi spostai a
Berlino. S’era nell’anno della presa del potere da parte dei
nazisti; e la grande cultura di Weimar non era ancora del tutto
spenta, ma era in agonia. Era, direi, il “crepuscolo degli dèi”.
Molti professori erano già con la valigia pronta; molti che poi
furono effettivamente costretti ad andare all’estero. Per esempio,
Werner Jaeger, la cui casa allora frequentai. Poi, ricordo, per
esempio, Romano Guardini, o Spranger. Ma il mio rapporto, a Berlino,
fu soprattutto con Nicolai Hartmann, di cui presi a frequentare il
seminario (non fu sempre un rapporto facile; ma su questo ora
sorvolo). E attraverso Hartmann scoprii Scheler (cosa che
naturalmente non entusiasmò Hartmann), che su di me ebbe molta
influenza.
In quella specie di
collegio in cui risiedevo a Berlino – si chiamava Hegel Haus, ed è
poi andato distrutto con la guerra – c’era già Claudio Varese,
qui presente oggi; e da lì iniziò la nostra amicizia. A un certo
punto arrivò Cantimori, anche lui con la valigia, ma, lui, perché
attraversava l’Europa in cerca di biblioteche. Anche con lui il
primo approccio non fu tanto semplice; però poi (doveva rimanere
solo pochi giorni, e invece rimase, mi pare, un mese) si strinse
allora un legame profondo fra di noi. In seguito, Cantimori l’avrei
ritrovato a Pisa, alla Scuola Normale, allorché nel 1939 vi fui
chiamato da Giovanni Gentile. Con Gentile ero entrato in rapporto
perché aveva letto la mia tesi di laurea, in occasione d’un
concorso a cui l’avevo presentata. Poi – dopo che ero entrato
nell’insegnamento – nel 1937 aveva appoggiato la mia richiesta di
trasferimento dal Liceo Scientifico di Livorno a Firenze.
Sennonché questo
trasferimento fu bloccato, all’ultimo momento, dal ministro,
Bottai, in seguito a un ricorso, ma in realtà, come venni a sapere,
per le cattive informazioni politiche su di me. Bottai rinfacciò a
Gentile d’andare a raccomandare gente sospetta; e proprio così
cominciò per me un rapporto, con Gentile, di grande franchezza
politica. Non direi che fosse un uomo complicato. Era un uomo di
potere, non c’è dubbio. Ma aveva anche una sua concezione –
diciamo “dialettica” fra virgolette – per cui era bene che i
giovani fossero ribelli, perché poi, dopo, sarebbero diventati
uomini d’ordine più saldamente. E fu sulla base di questa
concezione che diresse anche la Scuola Normale. Il trasferimento a
Firenze, l’ebbi l’anno dopo. Ma qui, nella nuova scuola, trovai
un’atmosfera, un clima, molto diversi, rispetto a Livorno. Qui,
c’erano i microfoni, in classe, e gli scolari, ogni tanto, me li
indicavano, perché, mentre parlavo, me ne dimenticavo. Sentivo come
un cerchio che si stringeva; cercai allora il modo d’andare fuori
d’Italia, e pensai d’andare a fare il lettore d’italiano a
Friburgo. Gentile lo venne a sapere, e mi chiamò a un redde
rationem. Io gli dissi – ormai, a quattr’occhi gli parlavo
molto francamente – che le cose precipitavano (si era nella prima
parte del 1939), e che in fondo Friburgo era solo a sessanta
chilometri dalla Francia (non so se era esatto, credo anzi che
geograficamente non lo fosse), e cioè che di lì sarebbe stato più
facile passare dall’altra parte. Allora, Gentile mi diede del
pazzo, accomunandomi ad altri che, egli sapeva, avevano avuto lo
stesso pensiero. Poi, però, venne la guerra, e io mi ritrovai con
l’impegno preso con il ministero degli Esteri, che ora insisteva
perché andassi a Friburgo, mentre naturalmente non ne avevo più
alcuna intenzione, proprio perché non sarebbe più stato possibile
un passaggio, di lì, dall’altra parte. Sennonché, una notte,
verso le due del mattino, ricevetti una telefonata, da Gentile, che
mi disse che era disponibile un posto di lettore di tedesco alla
Scuola Normale – evidentemente, non ci voleva mettere un nazista –
ma che non c’era tempo per decidere: dovevo farlo entro poche ore.
Io aspettai un momento, e poi gli risposi che accettavo. Dopo un
silenzio, lui commentò: «Così si decide la vita d’un uomo!». E
aveva ragione.
Non mi soffermerò
sull’ultima fase di Gentile, tragica. Ricordo solo che, certo
illusoriamente, cercai di persuaderlo a che si tirasse fuori dal
fascismo, nel frattempo divenuto la Repubblica di Salò. Nel novembre
del ’43, al Salviatino, dove abitava, ebbi con lui un incontro che
non finiva mai, perché non riuscivo a rimanere solo con lui. Quando
ce la feci, lo misi al corrente di quello che stava succedendo,
dandogli delle notizie che evidentemente non gli davano le autorità
fasciste – era stato anche ucciso uno del suo entourage – mentre
io le avevo dalla rete clandestina in cui mi trovavo. Me ne uscii con
la sensazione che forse qualcosa avevo ottenuto. Invece, non era
così: due giorni dopo, venne fuori che il ministro Biggini s’era
recato lì, al Salviatino, per offrirgli la presidenza dell’Accademia
d’Italia, e che Gentile aveva accettato (ma, quand’ero stato da
lui, non me l’aveva detto). E così s’avviò verso un destino di
cui in qualche modo aveva consapevolezza.
Potrei dire qualcosa
anche della cerchia di Benedetto Croce. Egli veniva ogni tanto a
Firenze, nei suoi viaggi. Io ero fra quelli che si raccoglievano
attorno a lui in casa di Luigi Russo; e si parlava delle cose più
varie (avrei da raccontare alcuni aneddoti). Poi, la sera, almeno una
parte di noi lo accompagnava, in corteo, all’Albergo Porta Rossa,
dove alloggiava. Ricordo che una volta, tornando indietro – eravamo
in via Tornabuoni – Raffaello Ramat, preso dall’entusiasmo,
disse: «è il nostro Socrate»; e io mi ribellai vivacemente. Era un
uomo di grande fascino culturale, Croce; ma no, io non l’ho mai
sentito come il mio Socrate.
Ora vorrei passare a una
questione più generale: che cultura avevamo, in Italia, negli anni
trenta. Beninteso, parlo qui dell’élite a cui appartenevo,
allevata per essere tale, secondo la tradizione della scuola
italiana, come scuola di classe, caratteristica che era stata
addirittura rafforzata dalla Riforma Gentile (chiamata, allora, la
Riforma Croce-Gentile); e quindi persone destinate alle professioni
liberali e all’insegnamento, tanto più allora che, per chi era
antifascista, non era praticabile la politica istituzionale. Ora, la
cultura fascista era, largamente, una fictio, se non per la
parte politica, per la teoria dello Stato (dallo Stato “etico”
s’era passati allo Stato “corporativo”, e alle diverse
interpretazioni di quest’ultimo: di sinistra, come nel caso di Ugo
Spirito, o non di sinistra). Ma per il resto la cosiddetta cultura
fascista non era che un’etichetta. Ricordo d’essere stato solo
due volte all’«Istituto di cultura fascista»: una volta, per
sentire Ungaretti che parlava su Leopardi, e un’altra per sentire
Corrado Pavolini (il fratello del famigerato Alessandro) che, non
privo d’una qualche finezza, parlava di cultura tedesca.
Un’etichetta, la pretesa cultura fascista; o una velleità di certi
letterati, come Papini, o Soffici, che noi disprezzavamo. La cultura
– pensavamo – era altrove; era nella «Critica» di Croce, oppure
nella «Civiltà moderna» di Codignola, che cominciò proprio nei
primi anni trenta, oppure nella «Cultura» di De Lollis, e così via
(naturalmente, rispetto al fascismo, c’era una doppiezza, in questo
sistema; il che a noi giovani cominciava a ripugnare).
Da un certo punto di
vista, la vera dittatura era proprio quella idealistica, nei suoi due
rami, crociano e gentiliano. Devo dire però che non mancava affatto
la possibilità di informarsi più largamente. Devo dire anche che,
in tutti gli anni trenta – e nei primi quaranta – fu molto
importante la letteratura, sia quella italiana sia quella non
italiana. Faccio solo dei nomi, di chi via via venivamo scoprendo:
Svevo; e poi Vittorini, che su «Letteratura» pubblicò
Conversazione in Sicilia; Gadda; poi (ma più tardi), Pavese;
ecc. E i poeti. Nella nostra gioventù, c’era una triade:
Ungaretti, Montale, Saba. Di quello che veniva da fuori, mi ricordo
che cosa voleva dire, ogni mese, l’arrivo della «Nouvelle Revue
Française». E Gide; Valéry; Proust. Non altrettanto potrei dire
della filosofia, per quel che ci veniva dalla Francia (Les deux
sources di Bergson non fece una grande impressione, almeno a
quelli come me), prima di – molto più tardi – Kojève, e cioè
della riscoperta, sotto nuova angolatura, di Hegel. Ancora, i
bagliori, i grandi bagliori, provenienti dalla cultura di Weimar;
Thomas Mann; poi, Kafka; poi, Rilke (ricordo le traduzioni da Rilke
di Giaime Pintor per la Einaudi). E non solo la letteratura, ma anche
il pensiero. Per esempio, si parlava di Freud, allora (qui, a
Firenze, da parte di Enzo Bonaventura). O di Max Weber (il libro di
Mario Manlio Rossi L’ascesi capitalistica di Max Weber
risale al 1928). Da Milano ci arrivava in qualche modo una parte di
Husserl. Dall’Inghilterra, la cultura del dopo-crisi. E sapete
tutti quanto operò, poi, il romanzo americano, per iniziativa di
Vittorini. Certo, molte di queste cose Croce le giudicava
negativamente, quando ne parlava nella «Critica»; e io ero tra
quelli che non l’accettavano. Comunque, tutto ciò tendeva a
rompere quello che altrimenti sarebbe stato un isolamento.
E quando, alcuni anni fa,
Arbasino s’è chiesto, degli intellettuali italiani di quegli anni:
«Perché non attraversavano il ponte di Chiasso?», ha dato un
quadro assolutamente falso, della cultura che vivevamo allora. Come
si sarebbero mai formati degli Chabod, o dei Cantimori, per limitarsi
agli studi storici, se il ponte di Chiasso non l’avessero
traversato? Poi, ancora, ci fu la scoperta, o la riscoperta, della
Russia; che, credo, fu molto condizionata, per opposizione,
dall’avvento del regime nazista in Germania. Mi ricordo quello che
fu il successo di Solochov, con Il placido Don, quando ne fu
tradotto il primo volume (gli altri, successivamente). Era una
società corale che in questo grande romanzo veniva come a
rispecchiarsi; questa era l’immagine che veniva fuori. Mi ricordo
anche che, alla fine del secondo anno che ero professore a Livorno,
nel ’37, venne una delegazione di studenti a chiedermi delle
lezioni supplementari. Credevo che volessero un aiuto per l’esame
di Stato; e invece volevano delle lezioni sulla Russia. Per un
attimo, pensai che fosse una provocazione; e invece non era così:
era un effetto, in qualche modo, anche delle mie lezioni (pur non
essendo io, allora, per niente comunista). A quegli studenti, dissi
che non sapevo molto più di quello che già gliene avevo detto; ma
ci mettemmo a far qualcosa, cominciando con lo studiare la
Costituzione sovietica del 1936, che nel frattempo era stata
pubblicata, in italiano, da un editore che si chiamava Grimaldi.
Mentre cresceva sempre
più l’inquietudine, lentamente in noi si produceva un
rivoluzionamento culturale – “molecolare”, avrebbe detto
Gramsci. Gli elementi di rottura, erano molto precisi. Per esempio,
col dannunzianesimo: forse nessuno è stato odiato più di Gabriele
D’Annunzio, dalla mia generazione. Un rivoluzionamento, dunque; che
tendeva anche a politicizzarsi, in modo del tutto indipendente dai
partiti politici che erano nell’emigrazione. E nascevano anche
nuove case editrici: basta vedere quello che fu il catalogo della
casa Einaudi, per vedere quale immissione di fatti e di problemi
nuovi – si andava da Trotzkij ai più recenti economisti inglesi,
come Keynes. Noi, eravamo uno strato sottile, modesto, di studenti,
giovani professori di liceo; e più o meno – parlo dell’Italia –
ci si conosceva tutti. Si veniva costituendo, direi, un nuovo
antifascismo, o almeno una nuova potenzialità di antifascismo,
indipendente, ripeto, dai partiti antifascisti dell’emigrazione. E
credo che questo sia molto importante, perché credo che senza questo
passaggio non si spiegano tante cose, a cominciare dai quadri
intellettuali della Resistenza, che i partiti organizzati non ebbero
nemmeno il tempo di formare; col che si avrà poi anche il
ricongiungersi con un movimento popolare. E neppure si spiega, direi,
quell’esplosione di idee che ci sarà dopo la Liberazione, quella
che Cesare Pavese, nel suo diario, uscito postumo, Il mestiere di
vivere, ha chiamato la «pienezza» degli anni ’45 e ’46.
Un momento di svolta era
stato la guerra di Spagna, con la scossa che produsse. Ricordo che
allora circolò clandestinamente, perché naturalmente in Italia era
proibito, il romanzo Les grands cimetières sous la lune d’un
cattolico francese, Bernanos, che in Spagna c’era andato dalla
parte di Franco, ma era passato in quella opposta. E, poi, il 1938;
l’anno delle leggi razziali, in Italia. Un anno decisivo. Fra
l’altro, anche quello in cui Croce ripubblicò Labriola,
accompagnandolo col suo famoso saggio Come nacque e come morì il
marxismo teorico in Italia. In un mio scritto, ho detto che, da
parte di Croce, questo era un «rischio calcolato», perché sentiva
che il marxismo tornava. Per noi, furono molti importanti allora, per
esempio, i Morceaux choisis di Marx, curati da Guterman e
Lefebvre; ma cominciavano a entrare anche altre opere, oltre che di
Marx (queste, in fondo, era più facile trovarle), per esempio di
Lenin. Proprio nel 1938 cominciò la crisi profonda del fascismo –
una crisi morale – in un processo di decomposizione all’interno
del Partito fascista stesso. Il clima cambiava. Si annunciava, in
qualche modo, anche la tempesta alla quale si sarebbe andati
incontro. Molti passarono allora dal fascismo all’antifascismo; e
alcuni di loro sarebbero poi caduti eroicamente nella Resistenza:
delle persone, quindi, con le quali era magari accaduto di discutere,
anni prima, sul loro fascismo.
Poi, la guerra. Rispetto
alla guerra, l’atteggiamento degli intellettuali antifascisti fu
vario; ché taluni ritenevano che comunque dovessimo entrarci. In
questa situazione, e nonostante tutto quello che si annunciava, noi
giovani antifascisti, però, sentivamo d’avere una qualche forza. È
il momento di certe riviste. Ricordo, per esempio, una rivistina,
«Argomenti» (dalla quale sarebbero derivati, nel dopoguerra, i
«Nuovi argomenti»), su cui pubblicai uno scritto in tre puntate.
Poi, naturalmente, fu proibita, per il tono antifascista che vi
circolava; ma intanto ne era uscito un certo numero di fascicoli.
Oppure, il gioco che veniva facendo Bottai su «Primato»; ma su
questo non mi soffermo, perché oggi se n’è scritto molto.
Comparve allora, in una collezione diretta da Gentile, anche il mio
libro Situazione e libertà nell’esistenza umana. Porta la
data del 1942; ma era uscito alla fine del ’41, perché mi ricordo
che per Natale l’avevo portato in omaggio a una ragazza che amavo,
e che oggi è qui presente (ma, devo dire, lei non si fece né in qua
né in là, perché era abituata a vivere tra gente che pubblicava
dei libri). Non era scritto per ragioni accademiche; ed ebbe una
certa risonanza anche fuori dalla cerchia dei filosofi, nonostante
che fosse d’un giovane sconosciuto. Ricordo come ne parla Pavese in
un capitolo del diario che già ho menzionato, Il mestiere di
vivere (Pavese non me ne aveva mai detto niente, e io fui
colpito, quando lo lessi, dopo la sua morte). Oppure, tempo fa,
Claudio Varese m’ha passato una bellissima lettera di Dessì,
sempre a proposito di quel libro. Lo lesse anche Mario Manlio Rossi,
allora professore a Edinburgo. Lo incontrai qui, alla Sansoni, e mi
disse: «Di qui, si va dritti al marxismo»; e io gli risposi: «No,
assolutamente no; anzi, è vero il contrario: è proprio dal marxismo
che io provengo» (un’incredibile, ancora, ingenuità, dire che
provenivo dal marxismo).
Ricordo anche che, nelle
nostre discussioni, i compagni liberalsocialisti mi dicevano sempre:
«Ma, allora, tu sei comunista»; e io mi difendevo da questa taccia
(era una taccia). Ma, in fondo, su di me, allora, avevano ragione
loro. Così, quando, oggi, ho una discussione con Bobbio, ho
l’impressione di continuare ancora, in condizioni mutate, quelle di
allora. Per diventare, poi, comunista, decisiva fu per me la lettura
di Stato e rivoluzione di Lenin, che mi passò Cantimori; ma su
questo non voglio ora inoltrarmi. Vorrei dire solo che tutto quello
che ho evocato finora ha un rapporto stretto con un’impresa alla
quale partecipai, subito dopo la Liberazione: una rivista, che si
chiamava «Società»; perché, almeno per la parte che mi
riguardava, che era poi quella programmatica, l’idea era d’una
saldatura fra quella cultura degli anni trenta di cui ho parlato –
quella rottura con il passato che eravamo venuti preparando
lentamente, modestamente, molecolarmente – e la cultura di quelli
che venivano da fuori, soprattutto i dirigenti comunisti, e
segnatamente Togliatti. Perciò, non ero d’accordo con Vittorini,
con la sua idea, nel «Politecnico», d’una “nuova cultura”. I
contenuti li avevamo in comune, più o meno; però io ero per un
continuismo, non assoluto, naturalmente, ma rispetto a quel che ho
detto; e scrissi anche un articolo, intitolato Rigore della
cultura, che aveva una parte di polemica con Vittorini, e che ora
ripubblico in un volume in cui, iniziando proprio con questo
intervento, raccolgo trent’anni di Polemiche marxiste. Dopo
i primi due anni, però, l’impresa di «Società» fallì; certo,
per debolezze nostre, culturali e politiche, ma anche non solo per
questo.
E qui mi fermo: non parlo
di questi ultimi trent’anni. Non parlo, per esempio, di quello che
è stata per me l’importanza, grande, della militanza in un partito
operaio, come quello a cui appartengo, e di ciò che ciò ha
significato anche per la ricerca e l’insegnamento: molto, anche se
non vorrei indulgere a troppo facili armonizzazioni a posteriori. Per
l’intellettuale – intendo per chi in qualche misura è un
produttore di conoscenza – è sempre tutto abbastanza difficile,
quando si sia anche impegnati direttamente nella vita politica.
Semmai, mi consentirei di dare una specie di indicazione per chi
s’incamminasse appunto per questa strada, peraltro affascinante, e
che io ho sentito comunque come doverosa. Anzi, due indicazioni. La
prima, di non diventare mai cortigiano, rispetto a chi ha il potere,
nelle organizzazioni di cui si faccia parte. La seconda, ancora più
importante, di non tenere troppo al proprio nome, quanto alle idee
politiche che uno riesca, o creda di riuscire, a elaborare. Quel che
importa è la loro socializzazione: che entrino, per esempio, nella
testa dei dirigenti. Ma, perché possano socializzarsi, queste idee
devono partire da esperienze reali, e in qualche modo avere un
rapporto con le masse.
Ciò non significa
sparire nell’anonimato, ma distinguere piani diversi: altra cosa è
il piacere, credo legittimo, anche sacrosanto, di vedere il proprio
nome sopra un libro o in fondo a un saggio critico, e altra è
appunto quel tipo d’elaborazione a cui mi riferivo. Per finire, o
quasi, prendo ancora qualche minuto, per esprimere la mia gratitudine
verso chi mi ha aiutato nella cosiddetta carriera accademica: anche
altri, ma, prima di tutto, Garin e Calogero. E per la Facoltà di
Lettere di Pisa, che mi tenne per quindici anni, non facili. Erano i
tempi della guerra fredda (e d’altronde allora non era tanto facile
neppure essere comunisti). Ho avuto la fortuna d’avere degli
scolari di grande valore e di averli in qualche modo aiutati a
crescere. Alcuni sono presenti. Nomino solo il più antico, Nicola
Badaloni, al quale sono molto grato che sia qui oggi. Poi, ci sono
quelli che hanno preso altre strade che non quelle dello studio. E
poi quelli scomparsi, che non posso non rammentare: Nicola Vaccaro,
che tanto avrebbe lavorato per le Lezioni d’estetica di
Hegel; e Carlo Ascheri, che ha lasciato una traccia indelebile negli
studi feuerbachiani, cominciando da un’esercitazione di Filosofia
morale, quand’era studente del secondo anno, a Pisa (ho ancora il
volume su cui avevo appuntato il suo nome, per quell’esercitazione),
e in seguito avrebbe avuto molto aiuto, in Germania, da Löwith.
Ho avuto la fortuna –
ma credo anche qualche merito – d’avere questi scolari. Invece,
non credo d’avere fatto una scuola. Io non l’ho cercata. Qualcuno
me l’ha rimproverato, per esempio, una volta, ricordo, l’amico
Vacatello. Può darsi che avesse ragione; ma questo attiene al modo
in cui uno sente l’insegnamento, che può essere molto vario. Penso
che, sul modo in cui lo sente, ogni professore, a un certo momento
della sua vita, dovrebbe fare un po’ d’autoanalisi. Forse, ci
sono come due poli estremi: un modo, che tende a una forma di potere
– non intendo potere accademico, ma intellettuale – e un altro,
per il quale non saprei parlare che d’una forma di eros.
Quest’altro, era il modo di Giorgio Pasquali. Ora, io non mi sono
trovato né sull’uno, propriamente, né sull’altro, dei due poli;
ma, certo, più vicino al secondo, e anche per questo a Pasquali sono
tanto grato.
Per concludere, ora,
davvero, vorrei dire che, nell’insegnamento della filosofia, ho
cercato sempre d’avere presenti due parametri. Uno, l’importanza
delle circostanze storiche, cioè culturali – circolazione delle
idee – e sociali. L’altro, la dimensione, per me irrinunciabile,
dei grandi pensatori. Per me, i grandi filosofi ci sono, continuano a
parlarci. Diceva Burckhardt (non a proposito specificamente di
filosofi, ma in generale) che la grandezza è un mistero; ma, io
credo, un mistero che poi si risolve, di volta in volta, abbastanza
empiricamente. Per me, i grandi filosofi sono quelli che, avessero o
no una grande cultura, sono riusciti a lavorare in presa diretta
sulla realtà. E quindi un primo compito è quello di ricostruire –
e, nell’insegnamento, aiutare gli studenti a ricostruire –
l’immagine della realtà, naturale, sociale, politica, che essi
hanno elaborato; perché di lì viene anche il loro retaggio teorico,
quello che ci hanno lasciato, che permane o che riemerge in certi
momenti della storia. Allora, in quest’ambito teorico, è possibile
anche, in certa misura, farli dialogare tra di loro. Penso che questo
sia importante di comunicare ai giovani. A me non piace, devo dire,
l’espressione “trasmissione del sapere”, mi piace piuttosto
“appropriazione”; e quindi: aiutare ad appropriarsi di qualcosa.
Ma rimane la questione della grandezza, che poi tocca anche il senso
della nostra misura, riportandoci a un’altra frase di Burckhardt:
«grandezza è ciò che noi non siamo». Grazie.
da “Il Ponte”, Cesare
Luporini, 1909-1993, numero monografico dedicato a Cesare
Luporini, anno LXV, n.11, novembre 2009