«At the Fights». Il pugilato
tra sport, spettacolo e letteratura
PER UN PUGNO DI DOLLARI
In un’antologia curata dai
giornalisti Kimball e Schulian, la nobile arte raccontata come evocazione della
storia sociale Usa.
Edita negli Stati Uniti, At the Fights è un’antologia che merita
attenzione: perché attraverso la raccolta di articoli e scritti sulla boxe
curata dai giornalisti sportivi George Kimball e John Schulian per i tipi della
Library of America (pp.517) si profila uno spaccato della storia degli Usa più
vivido e immediato di un trattato di sociologia o di una storiografia.
Che arriva al bersaglio pungendo
come un jab. Come quando Richard Wright, in High
Tide in Harlem, usa solo sette righe per lampeggiare il rematch tra Joe Louis
e il tedesco filonazista Max Schmeling vinto dal nero dell’Alabama per poi
filmare in un rutilante piano sequenza il giubileo di Harlem alla vittoria del
simbolo di una comunità esclusa e umiliata. E non era colpa degli afroamericani
– scrive Wright – se quel riscatto lo affidavano al pugilato visto che «non
avevano avuto dall’emancipazione altra possibilità di partecipare al processo della
vita nazionale».
Wright, iscrittosi al partito
comunista nel ’33 quando feroci erano gli effetti della Grande Depressione e
Hitler saliva al potere, fa pulsare quelle centinaia di migliaia di persone
tracimate dal ghetto che celebrava non la vittoria del Negro (così per decenni si
continuò a scrivere) sull’uomo bianco, ma contro il nazismo gridando «Tutti gli
ebrei sono contenti oggi» e issando striscioni «Abbasso Hitler e Mussolini».
At the Fights si impone come un’avvincente collezione di racconti ricchi
di metafore, immagini, dettagli, aneddoti e memorie sorretta da due big della
letteratura americana: Jack London – sul match tra Johnson e Jeffries, «la
Grande speranza bianca»: è sua l’espressione mai tramontata prima dell’attuale egemonia
dei pesi massimi cresciuti nell’ex-Urss – e Norman Mailer che con una miscela
visionaria di presa diretta e immaginazione confezionò il memorabile racconto
sulla sfida di Kinshasa tra Ali e Foreman. Mailer coniò l’espressione narrative non-fiction per classificare
il genere ibrido tra reportage e trasfigurazione creativa del suo The Fight che domina il corpo centrale
dell’antologia.
Non si pensi però che la collana di
perle che vi luccicano sia fatta di firme di giornalismo solo sportivo: sono
sceneggiatori, autori, scrittori che dal ring hanno estratto un’evocazione della
società americana trasposta anche in altri linguaggi – il cinema innanzitutto –
o soggetti narrativi. Leonard Gardner che scriveva di boxe per “Esquire” – e
che sarà per anni lo sceneggiatore del serial “NYPD Blue” - è l’autore di Fat City, la sublime novel che ispirò l’omonimo capolavoro di John Huston,
felice di affidargli la sceneggiatura che ha dato vita al più bel film attorno
alla boxe mai realizzato, quella Città Amara
del sottotitolo italiano dei perdenti del sistema americano. E di perdenti alle
corde di At the Fights ne pendono
parecchi: il pugilato è il solo sport che abbia per statuto la distruzione
fisica dell’avversario, dove il limite che non si deve varcare si spinge fino
alla fatalità che separa il k.o. dalla morte come in Then all the Joy Turned to Sorrow di Ralph Wiley, uno degli
scrittori afroamericani dell’ultima generazione, coautore assieme a Spike Lee; tramutandosi
perciò in un’universale metafora della vita che consegna ai suoi cronisti una
materia sanguinolenta e l’eroe solitario che vi si immola nel quadrato
sacrificale.
John Sullivan è il primo campione
del popolo dei migranti che sbarca senza posa a Ellis Island. Gli italiani avranno
l’imbattuto Rocky Marciano. Irlandesi, ebrei, italiani e afroamericani si
picchiano tutti contro tutti fin quando sul ring non salgono gli ispanici
ultimi arrivati sotto i lembi dell’american
dream dove fanno a pugni proletari di tutto il mondo: gli anonimi Firpo e
Brescia che denunciano origini italianissime nascoste sotto l’invariabile
nomignolo di Wild Bull of the Pampas che
accomuna i pugili venuti dall’Argentina, o il nigeriano Dick Tiger per cui il
ring è un’utopia oweniana a confronto dei massacri che sventrano il suo paese
nel ’68, avvisaglia degli orribili genocidi che avrebbero poi sfigurato
l’Africa di Ali e Foreman.
Lontanissimo dalla retorica
celebrativa è il crudo ritratto Pity the
Poor Giant tracciato da Paul Gallico (da un suo racconto Hollywood produsse
L’avventura del Poseidon con Gene
Hackman ed Ernest Borgnine, un Oscar alla musica e diverse nomination, il primo
film del catastrofismo in mare) di un patetico Primo Carnera carne da macello
per il circo boxistico della malavita. Mai fu pugile moderno – crede Gallico - piuttosto
«un cavaliere medievale che nel Trecento avrebbe vinto guerre gloriose a colpi
di mazza protetto da elmo e armatura», mentre sul quadrato era gigante dalla
mascella di cristallo: un’anfora di coccio che proveniva dal baraccone bonario dell’esibizione
finì frantumata dalla crudeltà dello show scandito dal profitto.
Da At the Fights trasuda un’altra delle verità che hanno fatto la boxe
materia di business e di linguaggi espressivi: la natura ambivalente tra sport
e spettacolo. Di Carnera ha scritto anche Budd Schulberg – qui grazie a The King is Dead – il solo al mondo ad
aver vinto un Oscar, per la sceneggiatura del suo romanzo Fronte del porto, e a figurare nella Hall of Fame dei memorabili della
boxe. L’ex-pugile protagonista del capolavoro di Elia Kazan con Marlon Brando è
ritagliato sui personaggi che Schulberg incontrò nella vita reale prima come
praticante e poi come scrittore. Ai suoi inizi il pugilato sportivo era uso
della upper class alla quale
apparteneva Schulberg, figlio di un produttore del cinema muto, e fra gli
universitari fino agli anni ’30: fu la Grande Depressione a diffonderlo nelle
classi subalterne come un mestiere per sbarcare il lunario. A Londra nel ’28 conobbe
il gigante friulano che negli anni bui gli ispirò il romanzo The harder they fall del ’47 sul quale
era costruito il film Il colosso
d’argilla (’58), l’ultima interpretazione di Humphrey Bogart.
La compilazione segue una
diacronia temporale riuscendo attraverso la catarsi del combattere a mettere
assieme senza distonie premi Pulitzer come Kempton e Remnick con le memorie dei
boxeur Patterson e Gene Tunney che – avido di letteratura già da pugile –
racconta il successo sul più terribile picchiatore della storia dei massimi, il
meticcio irlandese-cherokee Jack Dempsey. Ecco un’altra benemerenza di At the Fights: ti consegna la ricetta
per vivere l’emozione del match, inghiottirne l’adrenalina, patirne ansie e
attese senza rischiare di esser messo a dormire da un gancio
al mento. Ma non è la
playstation: pulsano sentimenti, si annidano riflessioni sotto gli occhi gonfi,
si consumano drammi, tracima umanità fuori del ring.
Nella stagione della lotta per i
diritti civili e del Black Power, George Plimpton, cofondatore di The Paris Review, ci porta al cospetto
di Cassius Clay – ancora per poco con questo nome – politicamente «guidato» da
un Malcom X che lo seguiva come ombra. Ali è onnipresente in At the Fights, come si deve al «più
grande» e alla carriera intrecciata di titoli, renitenza, battaglie politiche e
ring: leggendaria quella con Joe Frazier, appena scomparso il 7 novembre all’età
di 67 anni, culminata nel pathos distruttivo di Manila, in antologia con The
Fight’s over, Joe di William Nack.
Joyce Carol Oates ha scritto che la
boxe è il grande teatro tragico dell’America, il medium con cui la nazione ha
portato in scena ferite e valori, iniquità e mobilità sociali, business e
gerarchie, altari e polvere come accadde a Mike Tyson, di cui la Oates racconta
in chiave antropologica il significato della condanna per stupro che lo portò
in galera (Rape and the Boxing Ring).
Poi iniziò la deriva del pugile che aveva evocato l’incubo di Sonny Liston, il
«nero cattivo». Quando Tyson affronta Holyfield, afroamericano middle class integrato e timorato di
Dio, è lo scontro tra due mondi, rap contro gospel. Tyson, nella frustrazione di
una nuova sconfitta, gli strappa via con un morso il lobo dell’orecchio e firma
la fine della carriera (David Remnik, Kid
Dynamite blows up). «Il declino di un pugile si vede prima dalle gambe, poi
dagli amici», diceva Joey Giardello, alias Carmine Orlando Tilelli, boxeur
italoamericano di Brooklyn, una delle mille comparse di At the Fights dietro
le grandi figure, Robinson,
Duran, Ray Sugar Leonard, De La Hoya, Marvin Hagler; i maestri Angelo Dundee e
Cus D’Amato mistico e austero, l’uomo che per Patterson e Tyson – entrambi
usciti dal ghetto di Stuyvesant a Brooklyn - fu padre prima che trainer; i
promoter Bob Arum e Don King, diventati i padroni della scena dopo che la
commissione antimafia del procuratore Robert Kennedy nel ’61 aveva allontanato dalla
boxe Paolo «Frankie» Carbo e Frank «Brinky» Palermo – narrati da Barney Nagler
in James Norris and the Decline of Boxing.
Guardi la boxe e vedi l’America. Negli
anni ’70, sulla scia di Ali, a bordo ring cominciano a mostrarsi gli afroamericani.
È un sintomo di mobilità sociale. Caduta la barriera di genere, Katherine Dunn
traccia in The knockout il profilo
umanissimo di Lucia Rijker, la cattiva di Million
Dollar Baby di Clint Eastwood. Pagina dopo pagina i pugni scorticano la
vernice delle narrative «melting pot», «bianco/nero», «multirazziale», per
denudare l’osso della contraddizione di classe che nessuno dice meglio
dell’afroamericano Larry Holmes ex-campione del mondo dei massimi: «È duro
essere neri. Siete mai stati neri? Io sì, un tempo: quando ero povero». E allo
sguardo d’insieme, At the Fights
risulta uno splendido mural alla Diego Rivera sulla boxe come la storia sociale
giunta fino all’elezione di Obama alla Casa Bianca.
“alias – il manifesto”, 19
novembre 2011
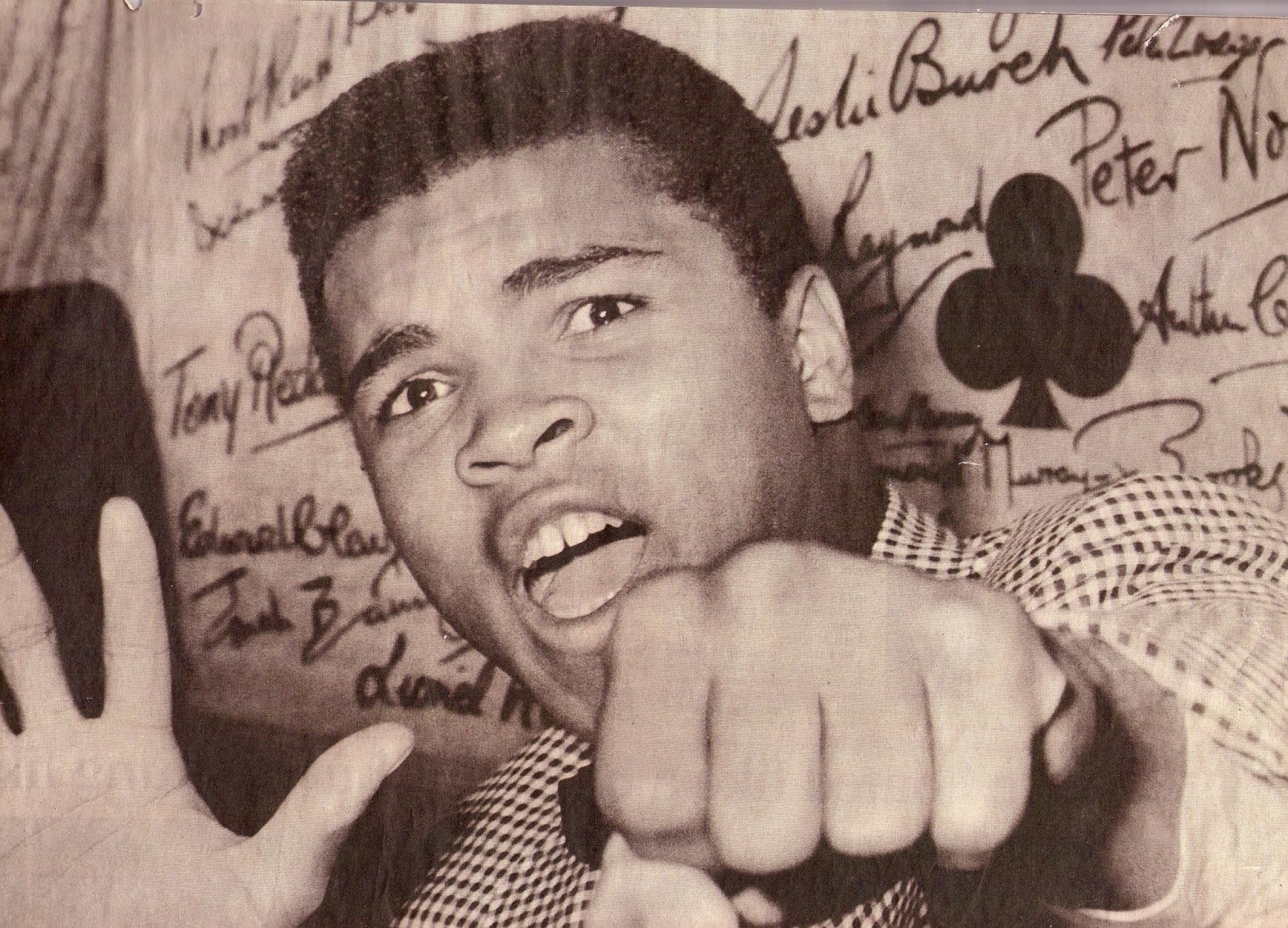
Nessun commento:
Posta un commento